Siamo rimasti così in pochi a essere scontenti di noi stessi
Marcello, La Dolce Vita
La fermata si trovava lungo un ampio corso rettilineo, interminabile, che dagli ultimi portici del centro si spingeva fino agli svincoli dell’autostrada. Là in fondo solo la cintura di asfalto della tangenziale separava gli ultimi edifici dalla campagna. Oltre c’erano le Alpi, e dopo tre giorni di bufera anche quella mattina il vento dalle valli si riversava in città rimestando le foglie sparse dei platani. Marco, sporgendosi dalla pensilina per cercare di individuare in fondo ai binari i fari del tram, lo riceveva dritto in faccia. Quel vento freddo che sapeva di neve gli piaceva: avrebbe lavato via il sonno, lo avrebbe richiamato al dovere del presente. Ci sono persone che al risveglio non ricordano dove si trovano, in quale stanza si sono addormentate e in quale riaprono gli occhi, come se avessero viaggiato tutta la notte smarrendo la via. Marco si perdeva nel tempo. Gli capitava di svegliarsi e non ricordare quanti anni avesse. Quante volte, riaprendo gli occhi, si era riproposto di telefonare a sua madre, morta cinque anni prima?
Il tram tardava e sotto la tettoia si erano radunate una trentina di persone che a turno compivano gli stessi gesti. Si affacciavano sulle rotaie, scrutavano la prospettiva del corso, tornavano a chinarsi sugli schermi, a sistemarsi gli auricolari.
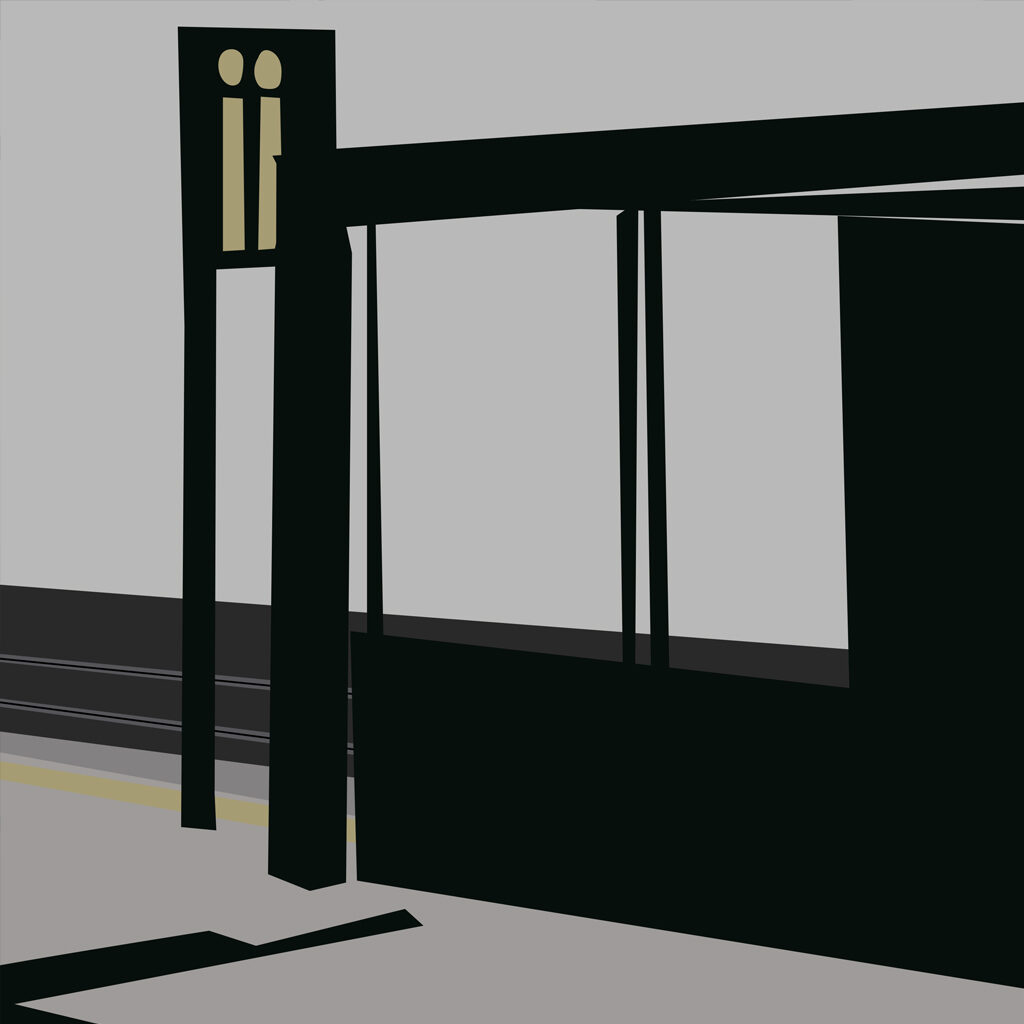
«Ha investito una vecchia» disse qualcuno, e subito, senza chiedere spiegazioni, un gruppetto abbandonò l’attesa e si diresse a un’altra fermata dall’altra parte della strada. Marco rimase al suo posto. Ora scorreva vecchi messaggi. Lo faceva senza interesse, per il piacere del tatto sullo schermo caldo. Cancellò il contenuto di un paio di chat di gruppo. Si chiese se non fosse il caso di tirarsene fuori, ma non sapeva se così avrebbe corso il rischio di perdere i contatti. Aprì la rubrica e fece scorrere le schermate. Ne aveva mille e ottocento.
Il gruppo in attesa sulla pensilina era ancora numeroso. Se molti si erano stancati di aspettare, altri ignari erano sopraggiunti. Le dicerie si arricchivano.
«Non è stato il tram, l’ha investita un camion. Ora non possono spostarlo dalle rotaie. Aspettano la polizia».
«È deragliato».
«È tutto bloccato».
«Non era una vecchia, era una ragazzina».
C’era davvero una scuola su quel corso, a un paio di fermate di distanza, e Marco tornò a sporgersi aguzzando lo sguardo lungo le rotaie che laggiù, dietro un turbine di polvere, sembravano invase dai fari bianchi delle automobili. Rabbrividì ripensando alla scena cui aveva assistito un paio di giorni prima, la ragazza che attraversava il corso a testa china con le cuffie nelle orecchie, lo zaino appeso alla spalla sinistra, penzolante, le mani impegnate a frugare in fondo a un borsellino. L’auto aveva accelerato, Marco ne aveva sentito il rombo in fondo allo stomaco. Non aveva forma, era solo massa e rumore. Sollevò il bavero del piumino e tirò la lampo. Chiuse gli occhi per richiamare il momento: lo zaino lanciato in aria e i fogli gialli e rosa che si staccavano da un raccoglitore. La ragazza, in piedi sul bordo della strada come se nulla fosse. Aveva schivato l’auto all’ultimo istante con una mossa da torero verso il marciapiede. Ma lo zainetto le si era sfilato dalla spalla ed era stato colpito in pieno, era rimbalzato sul cofano, poi l’urto col parabrezza lo aveva lanciato in aria. I fogli colorati ondeggiavano al passaggio delle altre auto, si posavano sull’asfalto, si risollevavano.
Marco riaprì gli occhi e vide che davanti alla scuola era tutto normale. Ricominciò a scorrere la lista. Gli sembrò assurdo che i contatti fossero ordinati per nome anziché per cognome e cercò nel menu delle impostazioni il modo di rimediare. Chi era quella gente? I dati se li portava dietro da anni, non c’era più modo di sapere a quando risalissero. Eliminò un paio di doppioni e riprese a esaminare l’elenco scendendo lungo l’ordine alfabetico.
«Basta, ora chiamo il numero verde».
Marco sollevò la testa: conosceva quella voce. La donna portava gli auricolari e parlava al telefono. Saliva spesso a quella fermata per poi scendere alla stazione. Era sui quarantacinque, con i capelli neri tagliati corti e un corpo minuto da podista. Vestita con ricercatezza aziendale – unico, studiato tocco di contrasto, i Doctor Martens rossi di vernice – portava uno zainetto piatto sulla schiena e reggeva nella mano sinistra una borsa portadocumenti di poliestere grigio. Durante l’intero tragitto, lo sguardo fisso davanti a sé, attraverso quegli stessi auricolari ogni mattina impartiva istruzioni a lontani, ipotetici collaboratori. Era scrupolosa e paziente, quasi materna. A forza di ascoltarla Marco era arrivato al punto di immaginarseli, quei collaboratori. Dovevano essere giovani e insicuri, una squadra formata da poco e che proprio per questo doveva crearle qualche ansia. Era certo che anche poco prima stesse parlando con uno di loro.
«Accidenti» imprecò la donna, «non lo trovo. Vado a prendere la metro».
«Aspetti, non se ne vada».
Lei si sfilò un auricolare.
Si guardò intorno, poi fece un passo verso di lui. I capelli corti le facevano un viso ovale da ragazzino pallido su cui spiccavano grandi occhi di un verde profondo. Il vento le aveva arrossato gli zigomi. Sembrava sorpresa ma non infastidita da quella intromissione. Doveva averlo riconosciuto. In fondo c’erano settimane in cui si vedevano ogni mattina e spesso avevano viaggiato fianco a fianco, lei parlando col suo ufficio, lui cercando di leggere o guardando fuori dal finestrino.
«Provo a chiamarla io la GTT».
Marco fece la sua chiamata e ascoltò il messaggio fino in fondo sotto gli occhi di lei.
«Il numero è inesistente o irraggiungibile».
La donna fece un altro passo e gli si mise al fianco, spalla a spalla. «Posso?» chiese, e diede una sbirciata al telefono di lui.
«Ma qui c’è scritto Greta».
Marco ricontrollò la lista e trovò l’ultima chiamata. Greta era il contatto che nell’elenco precedeva la GTT, l’azienda comunale dei trasporti.
Accanto al nome c’era una minuscola immagine rotonda. La sfiorò per ingrandirla. Ricordava bene la foto da cui era stata ritagliata. Greta adorava le foto e soprattutto i film in bianco e nero. A chi obiettava che erano più lontani dalla realtà replicava che era proprio così: cosa c’era di male a essere lontani dal caso e dal disordine? I film sono la vita senza il caos, diceva tirando in ballo Truffaut, ma a modo suo. Dovremmo imparare a muoverci, a fare l’amore come nei film. Dovremmo parlare solo con le battute dei film.
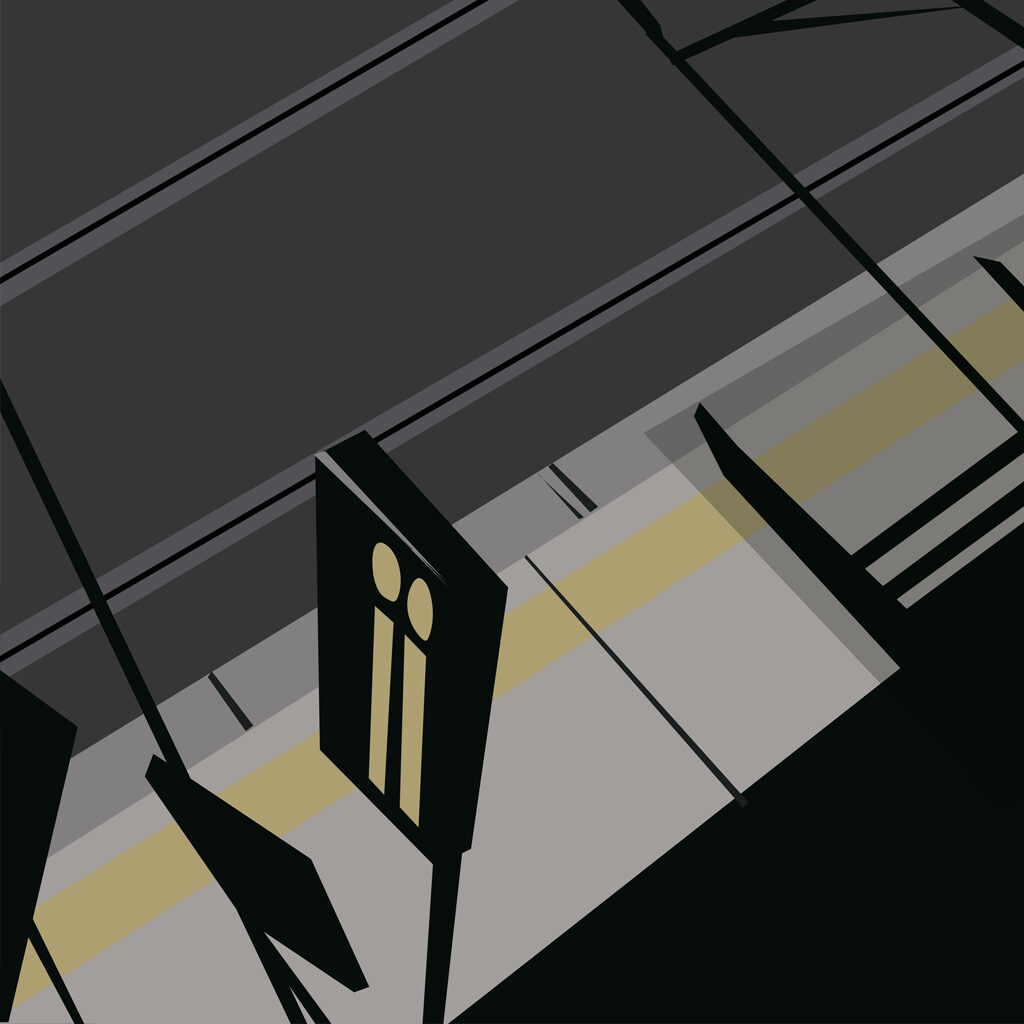
Nella foto il volto era ben definito contro lo sfondo sfocato in cui si riuscivano a distinguere il bancone di un bar, un tavolino, due palme, la sagoma di un passante in costume da bagno. L’aveva scattata lui durante una vacanza d’estate. Greta sorrideva senza imbarazzi, doveva averla colta di sorpresa. Non si riusciva a fotografarla altrimenti: appena si accorgeva dell’obiettivo la vita le fuggiva dal volto. Quando ripensava a lei la rivedeva con quell’espressione effimera e del tutto occasionale, non con quella dei tanti sorrisi raggelati dalla macchina fotografica. Si rese conto però che quel volto non aveva voce. La voce era definitivamente perduta. La consapevolezza dell’assenza di Greta si era consolidata al punto che certe volte Marco si chiedeva se lei fosse realmente esistita o se non fosse, piuttosto, il risultato di una prolungata operazione della sua fantasia. E pensare che proprio loro due ne avevano discusso tante volte: il ricordo di un fatto che ha davvero avuto luogo nel passato ha forse un diverso grado di realtà rispetto all’immaginazione di qualcosa che non è mai accaduto? Cosa cambia, se entrambi sono ormai scivolati nel non essere? Il dolore, quello cambia eccome, si disse Marco, il dolore cambia tutto. Ma questo all’epoca di quelle discussioni non avrebbe potuto saperlo, né Greta avrebbe mai accettato un’argomentazione del genere. Scosse la testa, il suo modo di allontanare un pensiero.
Il vento si ravvivò in una folata rabbiosa che gli tolse il fiato.
Avrebbe dovuto eliminare quel numero. Avrebbe dovuto cancellarlo da anni ma non sarebbe servito a niente perché era uno dei pochissimi, non più di tre o quattro, che ancora sapeva a memoria; era quello che non avrebbe dimenticato fino alla fine dei suoi giorni o della sua mente.
Marco rialzò la testa. La donna lo stava fissando.
«Siamo rimasti solo noi due ad aspettare questo tram fantasma».
A lui sembrò di riconoscere un ritmo. Era l’eco di un’altra frase. Ma sì, la battuta di un film. Arrivava da lontano ma era proprio lei. Inconfondibile. Non poteva sbagliarsi. Era uno dei film preferiti di Greta. Quando credette di averla indovinata, la perse. Ora la frase fuggiva da lui come una pietra che rimbalza sull’acqua, rallenta, ondeggia, sparisce nel silenzio e nel buio di un fondale. Marco non aveva la forza di inseguirla. Era così stanco di inseguire le ombre. Si lasciò cadere sulla panchina. Uno sciame di foglie scheletrite attraversava il cielo bianco.
«Io mi chiamo Elena» disse lei.








