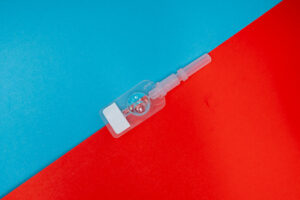C’è di mezzo il mare, anzi un intero oceano: mettere a confronto la politica italiana e quella americana è sempre un esercizio difficile e sdrucciolevole, che non di rado porta ad analisi sempliciotte e in definitiva inservibili. Certo, Donald Trump ha mostrato tante consonanze con la stagione del berlusconismo, ma ve lo vedete l’immarcescibile Silvio sostenere attivamente l’attacco violento di un manipolo di facinorosi alla sede del Parlamento? E sicuro, la deputata simbolo della New Left della costa Alexandria Ocasio-Cortez incarna alcuni aspetti di un populismo di sinistra visto anche alle nostre latitudini, ma qualcuno riesce a rimanere serio mentre immagina una «AOL» iscritta al Movimento 5 Stelle o a Potere al Popolo?
E così via, insomma. Ma in mezzo a tante finte somiglianze si trovano – accade con una frequenza sempre maggiore – anche consonanze di interesse. Quella che in tempi recenti si è fatta più immediatamente ravvisabile è da ricercare al di là dello steccato del progressismo, tra i nuovi padroni della destra internazionale, e ha a che fare con un termine-mondo sempre più in voga: le culture wars.
A destra le culture wars sono diventate il sale della contesa politica, tanto negli Stati Uniti quanto nella provincia dell’impero
Che cosa sono le «guerre culturali»? Qualche lingua affilata potrebbe rispondere che l’espressione denota anzitutto un luogo dell’anima, vista la grande facilità con cui viene applicata a pressoché qualsiasi diatriba, ma tentiamo una definizione: si tratta di quegli scontri simbolici che riguardano temi variamente connotati sul piano politico e ideologico, e oggi sfociano in redde rationem seriali amplificati e distorti dalle macchine impazzite dei social media.
A destra le culture wars sono diventate il sale della contesa politica, tanto negli Stati Uniti quanto nella provincia dell’impero, in forme che appaiono sovrapponibili. L’epicentro, in questo senso, è in Florida: qui il governatore Ron DeSantis, principale sfidante di Donald Trump alle primarie repubblicane per il 2024, le ha rese un’arma politica senza precedenti, monopolizzando l’attenzione pubblica e incanalando la dialettica elettorale in una serie di contese dall’alto profilo mediatico. La più celebre e attuale è quella che lo oppone a un pilastro dell’entertainment: Disney.
Rapido salto indietro nel tempo: è il 1967, alla Casa Bianca siede Lyndon B. Johnson, il mondo ribolle di proteste contro la guerra in Vietnam e gli hippie conquistano San Francisco con la loro controcultura oziosa e allucinogena. Il centro della Florida è ancora un poco appetibile susseguirsi di paludi e acquitrini, ma Walt Disney in persona, poco prima della sua improvvisa scomparsa avvenuta il dicembre precedente, si era adoperato per cambiare le cose: sapendo che «solo il 10% delle persone che visitavano Disneyland in California veniva dall’ est del fiume Mississippi», per citare Rick Foglesong, autore di Married to The Mouse, aveva individuato in quelle terre a sud-ovest di Orlando la nuova, ambiziosa direzione di espansione del suo impero.
Nel ’66 era nato ufficialmente il Reedy Creek Improvement District, dopo che la corporation aveva acquistato centodieci chilometri quadrati di terra per costruire il suo nuovo Magic Kingdom ed era riuscita a ottenere un upgrade fondamentale rispetto a Disneyland, il parco divertimenti situato sull’altra costa: nei suoi resort avrebbe avuto mano libera in tutto e per tutto, gestendo direttamente una serie di servizi pubblici, dalle fognature alla manutenzione stradale, fino alla risposta agli incendi. E, last but not least, sarebbe stata sottoposta a un regime fiscale vantaggioso.
Cinquant’anni dopo, la magia si è rotta: l’anno scorso una legge voluta da DeSantis, il Parental Rights in Education bill, anche nota come “Don’t Say Gay” ai suoi critici, ha ristretto le possibilità di insegnamento su orientamento sessuale e identità di genere nelle scuole pubbliche della Florida. E Disney non è stata a guardare: unendosi ad altri centocinquanta firmatari, ha criticato apertamente l’impianto legislativo e fatto donazioni a organizzazioni Lgbt+.
Nei quattordici mesi seguenti, e fino a queste ore, DeSantis ha destinato la quasi totalità della sua agenda a fare la guerra alla società di Topolino, che nel suo Stato dà lavoro a settantamila persone: negli ultimi mesi il governatore ha rimpiazzato il board che presiedeva il distretto speciale con un organo formato da suoi fedelissimi, minacciato di revocare lo status fiscale separato e affidato ai media una gragnuola di attacchi a Disney, definendo tra l’altro la sua intentata denuncia contro il governo «un espediente politico».
Ogni piccolo innesco di divisione politica esplode in un fuoco d’artificio di campagne martellanti
Walt Disney World non è che uno dei bersagli simbolici scelti dal candidato repubblicano in pectore, che solo negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per la sua opposizione strenua e ripetuta alle chiusure e alle mascherine durante il Covid; per aver chiesto alle università di fornire allo Stato il numero di studenti sottoposti a cure per la transizione di genere; più recentemente, per aver addirittura paventato che la sinistra, con quel suo ambientalismo fricchettone, stia tentando di togliere agli americani le loro amate tradizionali cucine a gas.
Ogni piccolo innesco di divisione politica esplode in un fuoco d’artificio di campagne martellanti e diversivi strategici, che DeSantis sa cogliere e sfruttare a suo vantaggio con una maestria che sta facendo scuola. Ma il valzer era stato suonato – seppure in forma minore – anche con Trump, l’attuale avversario del governatore, che per anni si è occupato di statue abbattute o presunte tali, luoghi pubblici intitolati a generali confederati, carovane di migranti e «teppisti Antifa» almeno quanto di economia, lavoro e fiscalità.

Non è la prima volta che la destra si compatta per prendere di mira bersagli politicamente propizi, intendiamoci, ma raramente prima d’ora i conservatori mainstream avevano reso le beghe simboliche e il complottismo più bieco le direttrici della loro azione politica.
Il trend, si diceva, è internazionale, oltre che sicuramente transatlantico: in soli sei mesi di governo, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha già reso il nostro agone politico un susseguirsi senza fine di schermaglie da rubabandiera, pensate ed eseguite più per far parlare di sé e del proprio posizionamento che per apportare un qualunque cambiamento al mondo reale.
Tutto si tiene, nel magico e assai lisergico mondo delle guerre culturali: per fare politica basta trovare un filone divisivo
Che dire della proposta di legge per punire l’uso dell’inglese nelle comunicazioni pubbliche ufficiali, con multe fino a centomila euro, per «proteggere l’identità nazionale»? Da dove viene quella che vieta la produzione – ma non l’importazione, giusto per rimarcare il suo carattere velleitario – di carne sintetica, al fine dichiarato di «tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare»? Per quale motivo un ministro della Repubblica ammonisce da un palco di un incontro pubblico a non «arrendersi alla sostituzione etnica», echeggiando una teoria cospirazionista da estremisti reazionari del sottobosco più nonsense del web?
Tutto si tiene, nel magico e assai lisergico mondo delle guerre culturali: per fare politica basta trovare un filone divisivo, banalizzato e rimasticato dagli algoritmi e sposarne l’incarnazione più semplificatoria e manichea. Il gioco è fatto: arriveranno sostenitori incrollabili e detrattori ingaggiati in servizio permanente, oltre a uno stuolo di amplificatori che non aspettano altro che un po’ di sano storytelling da guerra dei mondi. Come scrisse Neil Gaiman nel suo The Books of Magic: «Ci sono solo due mondi: il tuo mondo, che è il mondo reale, e altri mondi, quelli fantastici. Mondi come questi ultimi fanno parte dell’immaginazione umana: la loro realtà, o mancanza di realtà, non è importante. L’importante è che ci siano. Questi mondi forniscono un’alternativa. […] Non esistono; e quindi sono tutto ciò che conta».