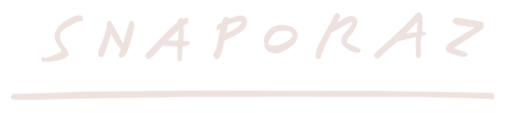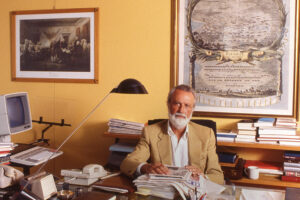Il 24 novembre 2022 è morto Issei Sagawa, “il cannibale di Kobe”, circondato da un risalto mediatico singolare. Il caso di cronaca che l’ha reso celebre risale al 1981, quando uccise, stuprò e divorò parti del corpo di una sua compagna di corso alla Sorbona, la studentessa olandese Renée Hartevelt. Il trentaduenne giapponese venne sorpreso dalla folla in un parco di Parigi mentre tentava di liberarsi dei resti del corpo della ragazza stipati in valigie troppo pesanti per il suo fisico esile. Sagawa fu considerato infermo di mente da un tribunale francese ed estradato in Giappone, dove fu giudicato affetto da un disturbo della personalità e rilasciato dopo appena quindici mesi di carcere. In patria, l’uomo divenne presto un fenomeno mediatico: autore di bestseller autobiografici, protagonista di film e spot televisivi kitsch, editorialista per un giornale nazionale e ispiratore di manga macabri. Una sua intervista pubblicata sul canale YouTube di «Vice» dieci anni fa conta più di diciannove milioni di visualizzazioni ed è un documento sconvolgente sui desideri atroci che abitavano quel corpo minuto, dotato di una personalità in apparenza docile e afflitta da un senso di colpa egoriferito.
Questo contenuto è visibile ai soli iscritti
Snaporaz è una rivista indipendente che retribuisce i suoi collaboratori. Per esistere ha bisogno del tuo contributo. Accedi per visualizzare l'articolo o sottoscrivi un piano Snaporaz.