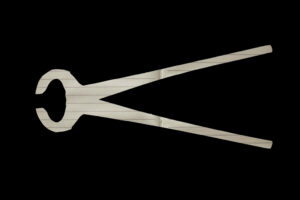Creode è un neologismo coniato dal biologo Conrad Hal Waddington per descrivere lo sviluppo seguito da una cellula, come questa cresce pur appartenendo a un organo più grande, che la comprende. La parola combina la radice greca di necessità (chre-) e sentiero (-hodos), il termine è stato ispirato alle proprietà biologiche delle cellule: quando lo sviluppo cellulare è disturbato da un apporto esterno, l’embrione regola la propria crescita e la differenziazione tornando verso la sua direzione di sviluppo originale. I testi di questa sezione provengono dall’incubo e dalla realtà in eguale misura e con la loro innocenza testimoniano l’assoluta permeabilità tra i due creodi, la loro funzione in una qualsiasi biografia umana, perfettamente interscambiabile. A riprova di ciò le immagini a volte confermano, a volte negano, amplificano e mistificano lo sforzo del singolo creode, commuovendosi di fronte al suo dolore oppure facendosene beffe, canzonandolo come si farebbe con un condannato di fronte al plotone d’esecuzione.
Le immagini ne rappresentano in maniera speculare la metrica: la forma è chiusa perché l’immagine è la metrica.

La stanza è attigua alla sala da pranzo. Il rettangolo di vetro è fissato alla parete tramite una rete di tubi in alluminio, la sua forma è simile a quella degli specchi che si trovano a volte nei bagni comuni dei reparti ospedalieri. E del resto anche l’aria lascia sulla lingua un sapore di medicinali, come nella camera di Rei Ayanami nel quinto episodio di Evangelion. Ma non si vedono garze, intorno, e bende intrise di sangue, nessun punto di sutura. Lui osserva senza riconoscere la canottiera logora e sbrindellata, i grossi buchi nel cotone tra l’elastico intorno al collo e il resto del tessuto. Prova vergogna per quella figura, prova vergogna per le lunette di grigio e di sporco nelle unghie che i genitori di E. osservano mentre mangia la carne, strappandola con le mani. Per migliorare la propria condizione decide di tagliare un dettaglio penzolante della maglia ma questo trascina con sé un’altra sezione dell’ordito, creando una voragine. Camminare in cerchio nella stanza è la prova che il massacro esiste e che lui è colpevole: nello stesso momento in cui ascolta la voce della madre di E. parlare al telefono, chiedere a E. come sta, come sta andando nella nuova città, vede per la prima volta il letto nella stanza. Non è rifatto, le lenzuola sono ancora calde, in una porzione di materasso ci sono un paio di calzini neri e altro intimo femminile. Li osserva mentre lo specchio si apre e la visione enorme sprofonda, due bambini di fronte alla pazzia del mare, ogni cosa nella stanza e dalle ossa ridiventa la città, il suo piccolo paradiso di viltà.

Avrà avuto cinque, o forse sei anni. La casa aveva un giardino, le aiuole non erano curate, crescevano elleboro e tarassaco comune, ideale per le pozioni guaritrici di Squall e Rinoa, soprattutto quando il composto viene diluito con acqua e calce in un bicchiere di plastica, poi lasciato a macerare sotto il sole. Che di certo non mancava nella casa, irradiava il suo sorriso, una cattiveria a trentasei denti che faceva piovere i finestroni della mansarda, nella strada e lungo i corpi dei passanti. Gli uomini e le lucertole del paese erano sopravvissuti a oltre duecento collassi radioattivi, coagulo di rifiuti tossici dai fiumi della provincia che riversano nel Tirreno le scorie di Chernobyl. Ma oggi sulle scale in calcestruzzo la mamma ha lasciato le buste della spesa, le cassette d’acqua minerale, profondissime le travi in truciolato, le caverne dei cattivi. I nazisti e il Doctor Octopus hanno rapito Polly Pocket, fatto a pezzi Mighty Max. Vedi il nonno se passa da qui giù, è cieco e vede l’aria con le mani, le protende mentre scende verso l’auto, nel garage, vedi adesso qui vicino, vedi il cranio tutto nudo sta arrivando proprio sotto le scale, perpendicolare all’acqua minerale, vuoi provare a spingere, a gettare la dinamite come hai visto nei cartoni, fare esplodere il burrone, se lo prendi cento punti, vuoi vedere che la botta gli fa bene e poi rivede, lo hai guarito, lo hai salvato ed è solo per scherzo se la luce è di nebbia, il sole si è smarrito, ha capito che la morte è più vicina quando sfiora con le mani di un bambino.

La piazza ha il nome di una pera ma la forma è più banale: ci sono dei tavolini e delle sedie, individui che con i loro occhi disperati sostengono da soli l’esistenza dei locali con le bevande colorate, gli spaccini, le signore con le buste della Conad che attraversano il quadrato in diagonale. Nel sogno, a più riprese, passa E., indossa il suo cappotto blu, è vestita con abiti scuri e ha gli stivaletti neri. Alcuni tra questi indumenti sono della realtà, altri, inequivocabilmente, appartengono al sogno. La pelle del viso e delle mani è interessata da un processo graduale di variazione del colore. Era bianca quando E. è apparsa fiondandosi verso il centro della piazza, tendeva al rosa soltanto sulle nocche e vicino le fossette del sorriso, cremisi sulla punta del naso. Adesso E. è ferma al centro del perimetro e la sua pelle assume velocemente tutti i colori che la lunghezza d’onda della luce consente di percepire: pensiamo di non aver visto nulla di più bello mentre E. continua a mutare fino a diventare opalescente, traslucida, un bianco che evidenzia tutte le vene e le arterie, le ossa e i legamenti del suo corpo. Soltanto C., tra i presenti, percepisce che quella mutazione equivale alla fine, e che una volta che il sogno o la metamorfosi si compiranno di E. e del suo bambino non rimarrà più nulla, sarà persa per sempre, intrappolata nei nostri sogni, nel luogo dell’incubo dove nessun sorriso del risveglio o bacio della buonanotte saprà raggiungerla. Soltanto C. si accorge e, accorgendosi, si sveglia e sorride.

È perché F.M.B. ha voltato le spalle alla vita, a tutte le abitudini, agli usi, alle consuetudini che facevano di F.M.B. l’individuo che tutti riconoscevano tra le iniziali del suo nome, che ancora se ne conserva la memoria? Le notizie sul suo conto arrivano dai coni d’ombra del pensiero e appaiono sempre lacunose e contraddittorie; per quanto ne sappiamo, vale la pena seguire queste tracce, con la speranza, e insieme il terrore, di riuscire a raggiungere ancora per una volta la sua voce, il teatro disadorno e in rovina dove F.M.B. insegnava ai topi le scorciatoie per procurarsi il veleno, ai topi infelici del collegio, a coloro che di passare dell’altro tempo insieme ai rantoli dei preti agonizzanti proprio non volevano che saperne e allora muovevano circospetti le loro zampette sopra e sotto l’impiantito in legno della sala, fra le travi del telaio, alla ricerca di un modo per farla finita, dal momento che quei topi sapevano benissimo che l’unica fase della vita degna di essere vissuta coincide con il periodo di massima espansione della propria quiddità di topo, uno spettacolo penoso è quanto viene dopo, insostenibile alla vista come il pizzetto di Dave Grohl o le rughe distratte di Peter Hook. F.M.B. riconosceva la malinconia esasperata che dai baffi propagava nelle spine dendritiche dei poveri animaletti e con le mani e le ciglia diceva: «non vi preoccupate topini, adesso morirete, un altro giro di accordi e niente potrà intaccarvi». Soltanto allora il rumore dei passi smetteva, noi ammutolivamo fingendo di essere su quel palco solo per caso.