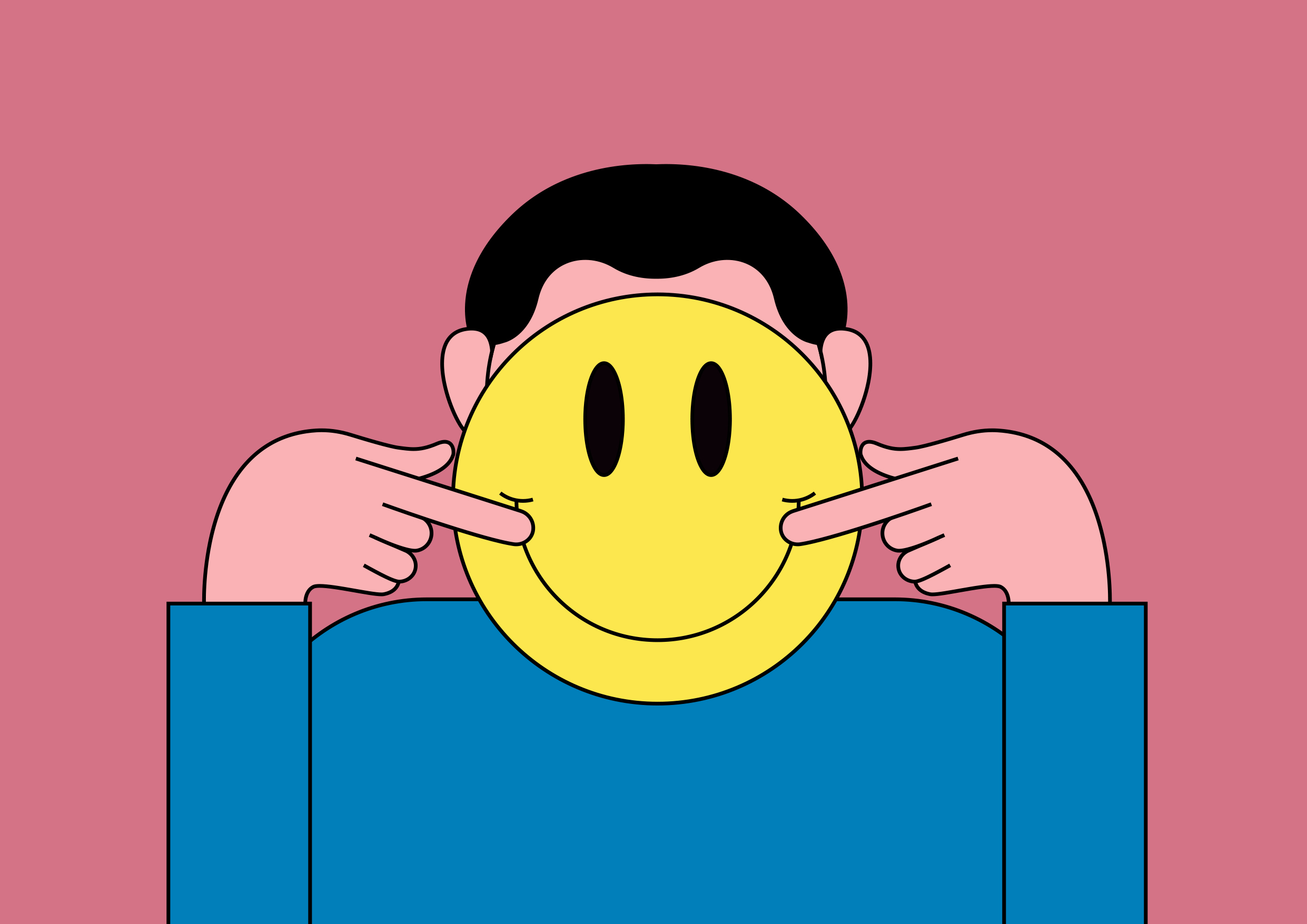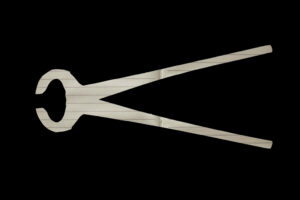C’è una casa editrice in cui lavoro da qualche mese, qui a Milano. La gente è fantastica, davvero. Non posso lamentarmi di niente. Praticamente sono un segretario. Ufficio Stampa, con le maiuscole, credetemi, vuol dire segretario. Non me ne vogliate. I libri li vedo, li sposto, non li leggo. Al massimo li imbusto. Li spedisco, li prendo a calci dentro le scatole. Potrei essere analfabeta. Oppure un robot.
In redazione volano bestemmie, scorrono flussi ininterrotti di mail, il caffè va come acqua. I miei colleghi, saggiamente, dicono che più che per il lavoro in sé un lavoro si sceglie per l’ambiente. Meglio fare un lavoro che non ti piace ma in un bell’ambiente, che un lavoro che ti piace ma in un ambiente di merda. Come dargli torto.
La mattina arrivo alle nove, fumo una sigaretta col fattorino all’ingresso, prendo i giornali, che arrivano ogni giorno mezz’ora prima di me, e salgo in ufficio. Ci sono solo io a quest’ora, gli altri arrivano dopo. Mi metto al computer e inizio con la rassegna stampa. Il sole mi entra negli occhi dalla finestra. Quando ho iniziato il sole non entrava dalla finestra. Ora sì. Le giornate si stanno allungando. Ogni giorno il sole mi rimane negli occhi un po’ di più. Tra due mesi avrò caldo.
Faccio la rassegna, la salvo nel server, la invio agli autori e agli agenti. Arrivano i colleghi. Due chiacchiere. Il mio lavoro, sostanzialmente, è leggere e rispondere alle mail. Un sacco di mail. E poi imbustare e spedire libri a giornalisti, attori, cantanti, influencer, gente che si spera li legga, li apprezzi, ne parli. Salgo e scendo dalla cantina portando di sopra o di sotto scatoloni di libri. Li prendo e li sistemo in ordine alfabetico negli scaffali. Aggiorno il server, le cartelle con le foto degli autori, con i pdf, con i materiali stampa italiani e stranieri, compilo i file. I file forse non si compilano, ma insomma. Scrivo schede di libri che non ho letto, che poi invierò a giornalisti, attori, cantanti, influencer, gente che si spera li legga, li apprezzi, ne parli. Controllo quanti follower ha su Instagram lo sportivo X, di cui a breve uscirà la biografia, e mando in anteprima il libro a chi tra i suoi follower ha più di X follower. Di solito sono giornalisti, attori, influencer… li legga, ne parli.

Pausa pranzo. Coi soldi non ti compri la felicità. Sacrosanto. Coi buoni pasto però non ti compri neanche un panino. Oddio, un panino sì, in realtà. Ma niente caffè. Insieme costa troppo.
Risalgo in ufficio e continuo a fare esattamente quello che ho fatto in mattinata. In più rispondo agli avvisi di giacenza dei libri che non sono arrivati a destinazione. Destinatario assente, trasferito, merce respinta. Mediaset ci respinge la merce. Non so se… Mediaset ci respinge la merce. Chiaro? A quest’ora, solitamente, inizio a innervosirmi. Dev’esserci un problema col centralino. Chiamo Mediaset. Mi mettono in attesa. Chiedo informazioni. Cade la linea. Fanculo… Perché il signor X non ha ricevuto il suo libro? Riconsegnate, per cortesia, l’indirizzo è corretto, arrivederci e grazie.
Bisogna fare un comunicato stampa per segnalare l’evento di presentazione del nuovo libro del signor X alla libreria di via X il giorno X. Bisogna fare un ordine di libri a magazzino. Bisogna inviare una copia omaggio del libro di X alla BookTuber X che vuole collaborare con noi, spettabile casa editrice, perché ama il nostro lavoro e vorrebbe tanto, ma davvero tantissimo, spettabilissima casa editrice, leggere il libro di X per recensirlo sul suo canale X. Bisogna essere cortesi e educati con tutti. Con i capi, con i colleghi, con i fattorini, con i signori X a cui s’inviano le mail e soprattutto con gli autori e con i capi. E con i capi. Bisogna organizzare gli eventi e pure andarci, agli eventi. E gli eventi di solito sono di sera, dopo le diciotto, oltre il termine dell’orario di lavoro. Bisogna lasciare una buona impressione. Bisogna essere brillanti, sapere tutto. La sera poi, alle diciotto o alle diciotto e trenta, o più tardi, se non ci sono eventi si esce dall’ufficio e si guarda il cielo. È già buio. Ma le giornate non si stavano allungando? Non sembra, veramente… La parola “libro”, la parola “evento”, pensi, mentre torni a casa in tram, non significano niente. Hai la sensazione di avere appena scoperto qualcosa. Ma non hai scoperto un bel niente. È solo nausea.
E il capo? Da dove arriva il capo? Il capo sta all’ultimo piano, è ovvio. Al vertice della piramide. Nessuno però l’ha mai visto entrare o uscire dalla porta che usiamo noi, che usano tutti. Arriverà dall’alto? Calerà dalle sfere dell’empireo direttamente sul suo trono, dietro la scrivania? C’è un passaggio segreto che collega l’ufficio a casa sua? Si teletrasporterà direttamente dal letto? Vive qui?! C’è da dubitarne.
Dal vertice della piramide discendono gli ordini. Diktat e desiderata, ultimatum e amnistie. Solo, trincerato nel suo ufficio, il capo, stregone nero dell’editoria nostrana, evoca demoni antichi da grossi volumi in folio, mormora con gli occhi rivoltati al contrario parole proibite in una lingua oscura, richiamando a sé potenze nefaste. L’aria gli ribolle intorno come se volesse squagliarsela, ma ormai è infetta della sua presenza, e si limita a sfrigolare, impotente, come olio esausto in padella. È inavvicinabile, incomprensibile, incontestabile – il capo. Pancia smisurata, testa glabra, tunica lercia color delle fiamme, e sbava, in trance, mentre parlamenta con l’aldilà, con le anime di chissà chi – e chissà come – che gli rivelano misteri, i segreti del tutto, le regole di micidiali anatemi.
Una stagista con in mano un caffè entra per errore nel suo ufficio. Somma sfortuna! Lui è in piedi che gorgoglia, le braccia tese sopra la testa, le mani ad artiglio che sembrano voler ghermire le molecole d’ossigeno via dall’etere impalpabile. La tunica gli scopre le braccia grasse fino al gomito. La stagista, si capisce, prende un colpo, poverina, si spaventa, è naturale, fa un balzo indietro e il caffè finisce a terra. Lui si gira di scatto, ringhia, lei si scusa, ma è spacciata, incenerita con un’occhiata. Uno schiocco di frusta e lei si sbriciola, sfarina come cenere, un mucchietto grigio sul pavimento e uno sbuffo di vento se la porta via. Morta una stagista, se ne fa un’altra…

Aleggia parecchia ironia nell’Ufficio Stampa di una grande casa editrice. Ho avuto un contatto con un sieropositivo dice al telefono un’anziana libraia preoccupata. Sarebbe meglio annullare l’evento. E giù risate. Chissà che contatto ha avuto. Ovviamente la povera libraia si è confusa, parla di Covid, non di Hiv. Be’, vorrà dire che ci terremo addosso le mutande. Non celebreremo gli usuali spargimenti di sangue post presentazione. E le orge? Peccato, neanche quelle.
Ironia, volgarità, cinismo, black humor da manuale. E tempi comici cristallini. Un esempio. Passi cinque minuti buoni al telefono con una giornalista – e si sappia, per inciso, che cinque minuti passati a fare una cosa soltanto, per un Ufficio Stampa, significano almeno quattro minuti sprecati. A sentirti, comunque, si direbbe che dall’altra parte ci sia la tua migliore amica. Ma non fatevi ingannare. Maximae virtutes del buon Ufficio Stampa sono un camaleontismo e una dissimulazione affabulatoria che manco se Cicerone, Churchill e Capote avessero avuto un figlio con Cleopatra sarebbe venuto fuori un Ufficio Stampa decente. Così, mentre con una mano reggi il telefono, con l’altra continui a rispondere al diluvio di mail che ti allaga la casella elettronica e, il diavolo sa come, in mezzo a tutto questo riesci anche a ridere, a chiacchierare, a sdilinquirti in microgossip da tredicenne e come sta tuo figlio e senz’altro cara, la promessa di spedire l’autore X al festival X della località X organizzato dall’associazione X – questo, de facto, è il lavoro, de iure non ne parliamo. Poi un saluto affettuoso, a presto, un abbraccio. E finalmente sbatti il telefono al suo posto. Quasi lo lanci. Il sorriso robotico che ti fiorisce in volto quando devi fingere di essere allegro e garbato appassisce di colpo, un vento moribondo ha soffiato, fulminando tutte le margherite del campo. Dai un’occhiata alla collega accanto a te, sbuffi, ti accasci sullo schienale della sedia e a quel punto, ma solo a quel punto, fai quella perfetta pausa a effetto che da sola vale il novanta percento di tutta la comicità di quello che stai per dire, cosa, questa, che se soltanto volessi ti farebbe salire ai ranghi del più raffinato umorismo da palcoscenico. Minchia, prorompi, con vaga cadenza siciliana – influenza del corriere catanese. Pausa. Che asciugo! E fosse per me a questo punto scroscerebbero gli applausi. Invece ricominci con mail, telefonate, agenda…

Se prendo la metro da Precotto intorno alle otto e un quarto, il che vuol dire uscire di casa intorno alle otto, il che, per me che ho un problema grave – voglio cagare, allenarmi, meditare, fare colazione, ascoltare un po’ di musica, leggere le mail, le notizie, scrivere, cagare di nuovo, farmi una doccia, vestirmi, uscire, tutto possibilmente senza essere in ritardo – vuol dire alzarsi intorno sei e mezza, vorrà dire che arriverò dove devo arrivare intorno alle nove meno venti, cioè l’ora in cui davanti al posto dove sono arrivato passano in rapida successione il tram X e il tram Y, quello che prendo io, che in poco più di dieci minuti, intorno alle nove, mi lascia dove mi deve lasciare. Lì c’è l’ufficio.
In metro leggo. Leggo in tram. Qualche volta leggo anche camminando. Dalla porta di casa a quella dell’ufficio sono all’incirca cinquanta minuti. Quelli sono i minuti, cinquanta all’andata e cinquanta al ritorno, che nell’arco della giornata posso spendere leggendo. La sera sono troppo stanco.
Tempo, denaro, monete, minuti, secondi, investire tempo, investire denaro, sfruttare il tempo, presumibilmente per fare denaro, monetizzare il proprio tempo, gestire il proprio tempo, gestire il proprio denaro, s-contare una pena col proprio tempo, pagare a ore, a tempo, risarcire qualcuno, in denaro, per il proprio tempo, tempistiche di pagamento eccetera. Notare come quasi tutte le espressioni che riguardano l’uso del denaro abbiano un corrispettivo precisissimo nelle espressioni che riguardano l’“uso” del tempo mette i brividi. Il denaro ha pervertito il linguaggio del tempo, inquinando la sua bella natura metafisica di sordida materialità economica. E sia come sia, stupisce che si conti ancora in decimi e centesimi anziché in sessantesimi. Per quel che mi riguarda, l’espressione più agghiacciante è far valere il proprio tempo. Come se non valesse già di per sé, il tempo. Come se ci andasse infilato dentro qualcosa a forza per farlo valere, come se altrimenti non valesse o valesse di meno.
In questi mesi ho notato che, mentre in altri momenti della giornata sulla metro leggono in pochi, la mattina, invece, molte più persone tengono un libro aperto davanti al naso. E non è solo perché alle otto di mattina la metro è affollata. Affollata lo è anche alle diciotto e trenta, quando è popolata da una foresta umana semisenziente di uomini e donne-albero che si reggono in piedi per miracolo, dondolandosi stancamente al ritmo delle fermate. Sarà che la mattina abbiamo tutti buone intenzioni, che la musica nelle orecchie dà fastidio, che la pinta di caffè bevuta a colazione inizia a fare effetto, non saprei. Ma l’impressione di entrare mezzo assonnato in un vagone libreria che scorre sottoterra è simile se non all’ovattata consapevolezza di una marcia comune quantomeno alla sensazione di una fregatura condivisa. Ci bagnamo tutti della stessa pioggia di scintille che brevemente ci illumina, che sprizza fuori dall’incessante martellare sull’incudine degli orari di lavoro, dei cartellini da timbrare, dei programmi da rispettare, degli obiettivi da raggiungere. Quelle scintille, quegli avanzi incandescenti sputati fuori dal grande meccanismo, sono tutto il nostro tempo libero – libero come sarebbe “libero” il tempo forzato che trascorreremmo in casa, barricati, a non lavorare, se fuori ci fosse una guerra. Qualcuno ha detto, secoli e secoli fa, che lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi (sempre soldi) il proprio tempo libero. Il tempo però, avrebbe risposto Ezra Pound (pound: soldi – ah!), con la sua barbetta elettrica: «Non è ancora diventato moneta, ma è quasi tutto il resto». Sia come sia, è comunque grottesco.

Gioite, da poco sono entrato a far parte della legione dei lavoratori. Già mi sento affratellato alla loro sorte! È tutto così tristemente eterno… Al momento, per la verità, sono stato inquadrato in quel reparto speciale di reclute che si chiamano stagisti, carne da cannone. Significa che faccio esattamente lo stesso lavoro dei miei colleghi, gli stessi orari, svolgo le stesse mansioni (su questo si potrebbe cavillare), ma non sono ancora considerato o considerabile un lavoratore a tutti gli effetti. È strano, se ci pensate. Il discrimine però è semplicissimo. È che non vengo pagato. E mi pare proprio che per definirsi o essere definito “lavoratore”, per avere i gradi, insomma, uno almeno debba essere pagato, no? Dalla cima della montagna, per tutta risposta, l’alto comando ruggisce così: serve l’addestramento, lurido pezzente, prima di ottenere i gradi!
Comunque, da un particolare punto di vista che oscilla buffamente tra un vittimismo fatalistico e un materialismo radicale, svolgere gli stessi compiti di tutti gli altri o, se il tempo è denaro, potremmo anche dire investire lo stesso tempo di tutti gli altri, e non essere pagato, non sembra né lavoro né sfruttamento, quanto invece una sofisticata forma di autolesionismo. E invece, invece… invece no, dicono – è sempre l’alto comando a parlare, che adesso però si fa suadente e biforcuto come un cobra. È necessario che sia così. Prima si impara. Prima si guarda, si fa e si impara. È apprendistato, praticantato, tirocinio eccetera. Eppure, capo, il tempo passa. E se non è del tutto tempo sprecato, il che in fondo è vero – perché s’impara un mestiere, s’impara a portare il fucile, a far la guerra, ci si guadagnano i gradi, le tacche e tutto il resto –, è sicuramente denaro sprecato, non intascato, perduto. Su questo non ci piove. Ma… scusi capo, il tempo non era mica denaro? Be’, cazzo. Lo vedete da voi che non è così semplice.
Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale: nessuna stagista è mai stata fulminata.