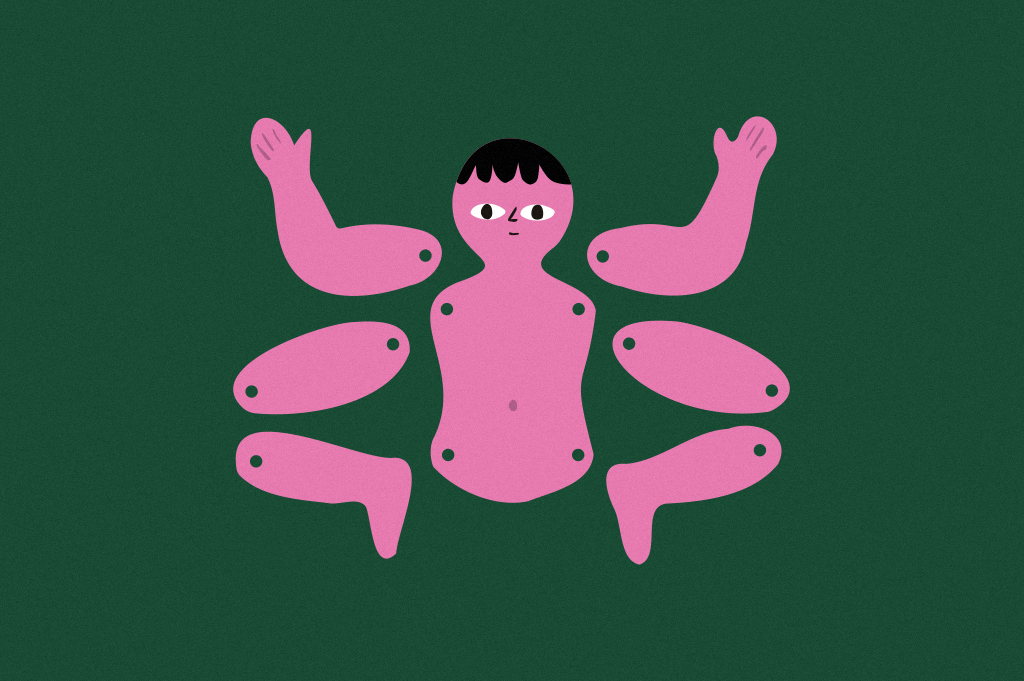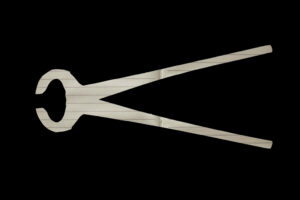Mi cospargono di borotalco e di crema idratante. Mi infilano il pannolino extralarge dai piedi, poi gli slip, la tuta con i giusti taglietti. La gonfiamo un po’ all’altezza dei fianchi e in altri punti con una pompetta portatile, tipo quella della bici. Indosso il busto, i cuscinetti speciali per il collo e le ascelle. Mi strizzano la pancia con il corsetto e le fasce (di solito ne servono molte). Facciamo passare le protesi sotto la seconda pelle e mettiamo ogni cosa bene in mostra. Siamo molto orgogliosi. A questo punto mi mettono i guanti: a volte bastano quelli corti, altre, invece, con gli abiti più smanicati, ci vogliono quelli lunghi fino alla spalla. Li lubrifico bene prima di metterli, altrimenti non passano. Alla fine scegliamo l’espressione, la parrucca, il trucco, il volto che desidero indossare: solleviamo tutto da un manichino di legno di cedro e sentiamo bene il rumore di risucchio, la nostra testa sgusciata, già pronta per l’uso. Per strada la gente si gira a guardarmi.

Quando ero piccolo mi accontentavo di un lenzuolo in testa, due fessure per gli occhi appena un po’ più grossi dei bulbi: ci pescavo i barbagli di luce. Mi andavano bene tutti i lenzuoli purché fossero scuri e di quel cotone grezzo, spesso, che mi nascondeva così bene. Mi piaceva rubarli dall’armadio nel sottoscala, tra le pile di scarti di tessuto polveroso che avevamo ereditato da una zia sarta: dovevano essere sue anche le forbici con cui bucavo i miei mantelli, per vedere quel tanto che bastava della mia casa d’infanzia; per essere visto quel tanto che bastava. Adoravo confondermi coi mobili o la tappezzeria, scegliermi cantucci oscuri della cucina o del salotto, tra i ripiani unti della credenza e i cassetti di legno tarlato, e aspettare che mi si venisse a prendere. Secondo mio padre, però, non si poteva semplicemente smettere di esistere, così, a piacimento. Una volta, per dimostrargli che si sbagliava e che invece potevo e che era proprio quella, anzi, l’indecente liberazione che cercavo nel mio gioco, inscenai il mio funerale avvolgendo la mia salma in un grosso drappo di seta nera e, da lì dentro, recitai una litania con parole inventate, scimmiottando un latino da vecchi ignoranti. Mi parve che ridesse un po’. A mia madre, invece, la voglia di cercarmi passava quasi subito.
Sprofondai allora in una serie di mascheramenti pretestuosi, senza futuro. Mi innamorai degli stipetti del ripostiglio, che cigolavano al sibilo del vento; del cestello del bucato e del sacco dei panni sporchi, che non aveva nemmeno un coperchio; scoprii un angolo accogliente nell’armadio dei cappotti fuori stagione, in vimini e bambù, ma fui costretto ad abbandonarlo dopo poche settimane perché ero ormai troppo pesante. La mia fame di nascondigli cresceva senza che nel frattempo riuscissi a trovare il modo di soddisfarla completamente. Seguì l’orrenda epoca dei sacchi dell’immondizia, prima quelli vuoti, poi quelli pieni: adoravo essere ripescato dalla donna delle pulizie in fondo alle scale, con l’odore di sgrassatore intriso fin nelle mutande; la bonarietà delle prime volte e la rabbia delle ultime, perché c’era da rimettere tutto a posto, ancora una volta. Finì quando quella domestica, al colmo dell’esasperazione, mi picchiò: lei fu licenziata ma anche io fui trasferito in una casa più piccola e senza armadi.
Dato che non potevo più nascondermi, volli provare a diventare ingombrante. Iniziai a mangiare ogni cosa. Ingrossai terribilmente fin quando mi resi conto che, per uno strano effetto ottico, nessuno badava a me più di prima. Anzi: ero gigantesco ed era come se fossi più nascosto che mai. Potevo fare le smorfie che volevo senza che nessuno facesse caso a me. Mio padre mi passava accanto, volgeva subito lo sguardo altrove e piangeva; la nuova domestica cucinava porzioni abbondanti di tutto anche se eravamo solo due (mia madre se n’era andata già da tempo). Essere ignorato così mi feriva. Caddi allora in uno stato di profondo intorpidimento: avevo appena undici anni ma compresi quasi subito che il mio appetito era insaziabile. Così decisi di smetterla con tutto: il cibo, le domestiche, i nascondigli.
Poi sono cresciuto, ho messo su un po’ di muscoli e i miei tratti si sono irrobustiti, diventando più simili a quelli di un uomo. Sono diventato un bell’uomo, da quando ho la barba e un po’ di bianco tra i capelli mi dicono che sono la copia di mio padre. Me l’ha detto anche mia moglie, poco prima di andarsene. Ha detto che sono grosso e debole, che è per questo che sono un caso disperato. Prima le ho riso in faccia e ho aspettato che sbattesse la porta per ripensare all’ultima volta che l’ha fatto mia madre con parole identiche, poi ho pianto, proprio come mio padre. La somiglianza tra di noi non mi era mai sembrata così liberatoria.

Da allora siamo migliorati molto. Mi aiutano in diversi a vestirmi, ci aiutiamo a vicenda. Possiamo piangere e nessuno ci vede. Non sentiamo nemmeno le porte che sbattono perché la gomma anestetizza ogni cosa. Siamo tutti ormai così lontani. E poi, per aggiustare il silicone alle orecchie di carne (non è semplice farle coincidere alla perfezione) servono diversi pizzicotti, schiocchi secchi di pelle sintetica che possono pure stordire per un po’. Anche se adesso stiamo più attenti di prima, a volte capita ancora e quando capita mi sa che sorridiamo tutti insieme. Io digrigno i denti quel tanto che posso. Poi è tutto in discesa. Sudo appena. Abbiamo trovato da tempo il giusto compromesso; non mi sconvolgono più le appendici di cui mi rivesto. Allo specchio sono sempre più me stesso. La maschera è il solo peso che possiedo.
Non è un peso indifferente. La sola tuta gonfiabile con tutte le sue estensioni può andare dai cinque ai dieci chili. Adesso so che si basa tutto sul giusto equilibrio. C’è stata la fase dei marciapiedi e dei parchi, quella della provocazione nelle piazze; c’è stata una fase che è durata molto, quella della volgarità. Se riuscivo a contare fino a cinque si stupivano: fingevamo di credere di non avere niente nel cervello. Tiravo su la gonna e mi dicevano che ero una puttanella: “dovresti vergognarti”, urlavano sguaiati puntandomi il dito contro. Ci divertivamo molto insieme. Adesso, dicevo, ho una certa età e sento che mi manca qualcosa. Non pensavo di riuscire a essere madre (per mia moglie non potevo fare il padre, per mio padre non sapevo essere figlio. Per mia madre, invece, non dovevamo esistere e basta. Non ha mai creduto niente di me, anche se sapeva che dietro la porta che stava sbattendo c’eravamo io e suo marito, entrambi in lacrime, mi pare).
Quindi sono migliorato ancora, ho inventato la moda dei bambini reborn. L’ho portata tra gli amici che ho conosciuto online, nella community italiana dei Female Masking: dicono che sono di ispirazione, nessuno si nasconde più dentro casa, ho allargato i loro orizzonti. Mi dicono che ho molta più classe delle loro mogli, che sono molto più triste di loro. A qualcuno di noi adesso piace muoversi a scatti, produrre il cigolio della merce scadente, sentire i propri passi appesantiti dai tacchi. Io mi guardo allo specchio e invece di farmi la barba me ne vado nel mio guardaroba, indosso la mise per spolverare oppure quella per chattare con altri uomini fragili. Altrimenti prendo il mio bimbo di plastica. Allora sono calma, calmo, deserta, puro. Quando stringo la testa dentro il passamontagna di gomma l’aria mi basta appena, ma il carnevale che mi sono inventato è il periodo del mese che preferisco. Lo sfrigolio che fanno la mia pelle e la sua quando si toccano, quando ci tocchiamo: questa è una mascherata come si deve. Sotto quel lucido strato di lattice sono sana, tranquillo come mai. Nessuno ci guarda e noi non guardiamo nessuno, solo questi guanti di gomma pregiata che cullano un bimbo sintetico: qui siamo tutte rinate. Inspiro. Lo vedo. Espiro.