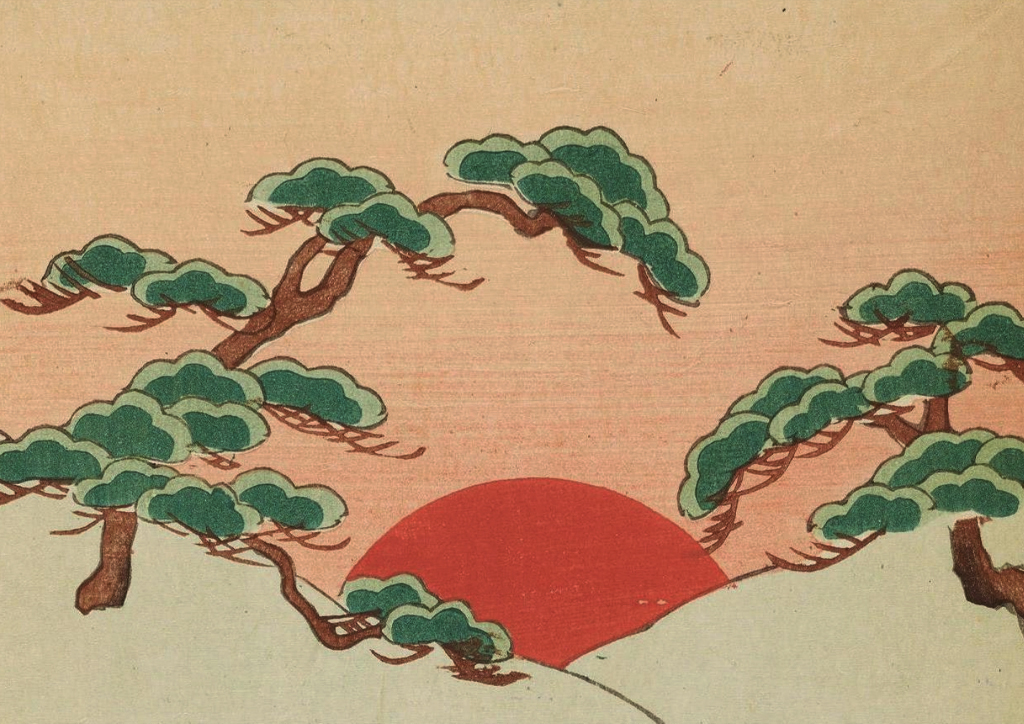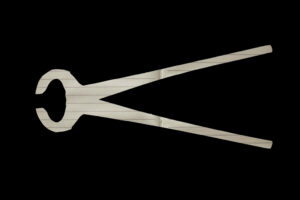La luce dell’alba illumina il mare interno di Seto e Osvaldo Nocciola, come ogni giovedì da qualche anno a questa parte, si risveglia nel corpo di un’anziana e minuta signora giapponese. Conosce bene questa baia, è già stato altre volte a Naoshima. Però, nonostante lo splendore del paesaggio, nonostante la vista sfumata e dolce delle altre isole lontane, Osvaldo avverte un dolore improvviso, netto, definitivo. Perché se si trova qui, allora la terapia non ha dato esito positivo.

I primi giovedì in cui Osvaldo si è risvegliato nel corpo della signora Yuko Nabeta ebbe l’impressione di essere impazzito. Nelle prime tre occasioni si sentì svenire e passò il resto della giornata in uno stato di catalessi totale. Il fatto di ritrovarsi a gestire un corpo non suo, sommato alla capacità inspiegabile di poter comprendere e utilizzare il giapponese come se fosse un madrelingua, lo costrinsero all’immobilità e al mutismo più assoluti. Chi avrebbe mai potuto credergli se avesse provato a spiegare ciò che gli succedeva? Meglio, molto meglio fingersi malato, restare a letto e aspettare che il venerdì lo riportasse alla sua vita, in Italia, a sua moglie, al suo lavoro di selezionatore di film per festival cinematografici. Cercando il più possibile di non farsi sopraffare dall’angoscia, perché sì, lui poteva provare a limitare i danni, in Giappone, restando catatonico, ma nel mentre cosa ne era di lui, del suo corpo? C’era qualcuno impegnato a sostituirlo? A giudicare dalle reazioni dei suoi cari e dei suoi colleghi, chiunque fosse, stava facendo un ottimo lavoro. Il venerdì infatti ritornando nel proprio corpo, Osvaldo ritrovava la sua vita in qualche modo migliorata. Quasi che il giorno di pausa da se stesso coincidesse con la migliore versione di sé, come se l’Osvaldo Nocciola che lo sostituiva fosse portatore di gentilezze, accortezze e slanci di cui lui, da tempo, non era più capace. Troppo preso da un lavoro che amava sempre meno, costretto a inseguire il gusto mutevole dei suoi colleghi più influenti. Nei giovedì che lui trascorreva a letto, in una splendida villa a Tokyo, il suo sostituto invece sembrava in grado di scardinare l’asfittica architettura in cui Osvaldo stesso aveva obbligato la propria esistenza, offrendogli una freschezza e uno sguardo nuovi.

Chi poteva riuscirci disponendo di un solo giorno a settimana? La risposta arrivò il quarto giovedì, e ovviamente fu la più ovvia: si trattava di Yuko Nabeta stessa. I due, quindi, si davano il cambio. Fu proprio Yuko a spiegarlo a Osvaldo, lasciandogli una lettera nascosta sotto il cuscino e iniziando così una corrispondenza privata che da quel giorno non ha fatto che intensificarsi. La novantenne giapponese in quel primo messaggio lo supplicava di provare a vivere questa loro assurda condizione senza far preoccupare l’anziano marito. Nemmeno lei sapeva trovare un senso a tutto ciò, ma gli proponeva di vivere questi giovedì come una sorta di allucinazione consensuale. E in effetti, Osvaldo si ritrovò costretto a dirsi d’accordo: resistere non faceva altro che complicare una situazione già complessa. E così, con una naturalezza e una rapidità persino più incredibili della condizione stessa, Osvaldo finì con l’abituarsi a questa pausa obbligata. Anzi fece di più, prima iniziò a trovarlo interessante, e poi piacevole, e infine il momento più atteso e importante della settimana. L’idea di sapere il proprio corpo e la propria vita in buone mani, il sollievo di sapersi parlato e vissuto da una persona che col passare del tempo gli sembrò sempre più incredibile, infondeva in Osvaldo una gioia nuova. Una felicità che andava a moltiplicarsi grazie al tempo trascorso nel corpo di Yuko, all’interno della sua vita lenta e silenziosa, in cui l’enorme ricchezza del marito sembrava incaricata di un’altrettanto lenta e silenziosa esplorazione del vuoto: enormi e silenziose e vuote erano le stanze della loro villa, enormi e silenziose e accoglienti erano le sue ore. Il marito di Yuko era quasi sempre in viaggio, nonostante l’età era spesso costretto a presenziare a cerimonie ufficiali riguardanti l’azienda che lui stesso aveva fondato e fatto prosperare. E allora Osvaldo camminava per le strade di Tokyo: ogni giovedì si faceva condurre dall’autista in un diverso quartiere. Perlustrare quelle strade nuove e inusuali potendo contare sulle memorie di Yuko, gli regalava la sensazione di raddoppiare la realtà, di sdoppiarla. Negozi di libri usati, giardini pubblici, folle sovrastate da neon a forma di granchio, ristoranti aperti tutta la notte, grattacieli, altari, rotaie, stradine piene di bar minuscoli, artigiani intenti ad affilare lame, centri commerciali dedicati al modellismo: Osvaldo era ammirato dalla dedizione con cui i giapponesi svolgevano qualsiasi mansione, anche quelle che dal suo punto di vista avevano poca importanza. Si rese conto di non aver mai dato il giusto peso alla manutenzione del presente, preferendogli una sterile ossessione per il futuro prossimo, immancabilmente raggiunto con l’amarezza del giocatore che non vuole abituarsi alla sconfitta ma che nemmeno crede nella vittoria.

Purtroppo o per fortuna, questo è impossibile da stabilire, quei primi tre giovedì di catalessi simulata, obbligarono Yuko a svolgere esami medici che finirono per svelare una grave malattia di cui lei, senza saperlo, soffriva da tempo. Malattia che negli anni di condivisione con Osvaldo è progredita in maniera più netta, e che ormai sembra essere giunta al passaggio finale. Nell’ultimo messaggio recapitato a Osvaldo, Yuko lo aveva informato: se le cose dovessero andare male, la prossima volta ti sveglierai a Naoshima, perché voglio vedere ancora una volta le ninfee di Monet. Il marito di Yuko fu uno dei principali finanziatori dietro agli interventi architettonici eseguiti da Tadao Ando sull’isola. Non volendo trasfigurare la bellezza del luogo, l’architetto realizzò edifici scavati nel terreno, quasi invisibili se non osservati da una prospettiva aerea. Anche il Chichu Museum, che ospita le ninfee di Monet, dall’esterno risulta poco comprensibile, per capirlo e apprezzarlo, bisogna entrare al suo interno. Osvaldo Nocciola ha la possibilità di farlo in perfetta solitudine, prima dell’orario di apertura. Le superfici di cemento armato che caratterizzano lo stile di Ando, qui raggiungono un grado di perfezione tale da farle sembrare quasi sfumate, come se il dialogo tra ombra e luce diluisse il grigio delle superfici in modo da risaltare le linee esterne. Osvaldo osserva le dita di Yuko scorrere sul corrimano, vede un prato verde racchiuso nel cortile interno, poi un giardino di pietra: ci sono così tanti tipi di grigio e così poco tempo per trovare le parole giuste per definirli. La stanza in cui si trovano le ninfee di Monet custodisce un biancore soffuso prodotto dalla luce naturale che dal soffitto si riflette sul pavimento. Un pavimento composto da piccoli dadi di marmo bianco disposti l’uno vicino all’altro senza fughe a unirli tra loro, di modo che un altrettanto tenue reticolato di ombre finisca per dare l’impressione di camminare sospesi, sospesi e sospinti verso queste grandi pitture. Osservando le ninfee di Monet, pulsanti, dolcemente spettrali, Osvaldo Nocciola legge quella che con tutta probabilità sarà l’ultima lettera di Yuko. Si tratta di una poesia di Emily Dickinson. Ma soltanto rileggendola una seconda volta, Osvaldo Nocciola capisce come il saluto iniziale con cui prende vita un’amicizia, o un’amore, contenga già al proprio interno, luminoso e ampio, il fiato con cui ci si dovrà, poi, dirsi addio:
Dura un dominio finché lo detieni –
un possesso altrettanto –
ma queste – che donate si dileguano
appartengono in eterno.
Quanto perenni sono le labbra
note solo alla rugiada –
Spose della permanenza sono queste –
che me e te soppiantano.