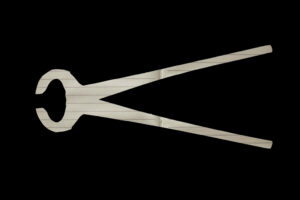Non ho mai visto un film porno: non provo interesse per la carne svestita, l’accoppiamento fra portatori di genitali, l’amplesso come cardine dell’intreccio. È per questo che quando è accaduto la prima volta non avevo idea di cosa fosse, tutta quell’acqua. A dirla fino in fondo non l’avevo manco vista: fu lui ad avvisarmi, non senza malagrazia: Giada, hai fatto un lago. Ma come ci eravamo arrivati a quel punto? Ero da lui per un colloquio di lavoro, io che un lavoro, come dice un verso di Gilda Policastro, non l’ho mai voluto cercare. E allora perché c’ero andata? Non sa, non ricorda. Ero lì come tante altre volte sono stata in posti che non avevo scelto e in cui non mi sarei mai voluta trovare. Metti, una sala d’aspetto. Il mio culo è vergine, non per i medici. Il corpo che svesto senza imbarazzo soltanto negli ambulatori ha ospitato tubi in anfratti che non saprei nominare, credo ovunque fosse possibile intruderli, ma dormivo. Non sa, non risponde. Al risveglio, facce di infermiere mimano ok. Questa volta non è altrui, la diagnosi che aspetto. Ho dato precise istruzioni che sia io a riceverla e non il mio accompagnatore, un collega con l’aria di chi in effetti si è trovato invischiato in quest’accollo senza compartecipazione né obbligo. Giada? Ed è lì che apro gli occhi, realizzando di trovarmi in una sala nuova, diversa da quella dell’indagine diagnostica invasiva.
Questo contenuto è visibile ai soli iscritti
Snaporaz è una rivista indipendente che retribuisce i suoi collaboratori. Per esistere ha bisogno del tuo contributo. Accedi per visualizzare l'articolo o sottoscrivi un piano Snaporaz.