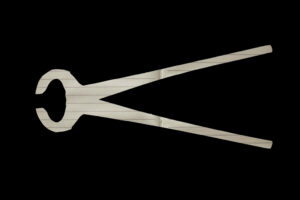La mia deflorazione è post lauream, come il master. Anzi, durante il master: il bellissimo e sprucidissimo M mi guarda da un po’. E poi mi invita da lui. E poi quasi non crede alle sue orecchie quando gli dico che è la prima volta (gli risultavo, come di fatto ero, fidanzata). Dopo l’immemore performance (io la parte stoccafisso, lui l’affumico) mi chiese irresistibilmente: non vorrai mica un po’ d’affetto. Uno dei rari momenti di intimità, la risata conseguente, dell’intera mia vita sessuale. Gestii malissimo quel che ne seguì, fino a compromettere il fidanzamento ufficiale, e fu tutto. Anzi no: anni dopo mi capitò di incontrarlo di nuovo, M, sulla via per il Policlinico dove avevano ricoverato la madre (la mia: lui l’aveva persa a 16 anni). Era andato a vivere a Londra, tornato per pochi giorni, sistemava cose, un po’ di chiacchiera, ciao e ciao. “Non posso pensare di vivere la vita nella stessa parte di mondo”, questa nemmeno avrei dimenticato. Ogni tanto lo googlo, M, ma non esiste più, nell’internet.
Però nel catalogo c’è, ed è il primo della lista, la seconda. E sì: avevo dapprima un catalogo per non perdere il conto dei ragazzi che baciavo, finché baciavo soltanto. Mi sembri un campo minato, disse il (credo) quindicesimo: qui sì, qui no, uno strazio. Effettivamente, per quella faccenda del seno, di cui non avevo registrato, nel tempo, alcuna sensibile efflorescenza, restavo una delle poche ragazze, a detta dei maschi, che piuttosto si concedeva ai palpeggiamenti bassi, per la maggioranza delle suddette off limits. Presumevo non ci fosse gran variabilità, nel laggiuso, rispetto ai rigonfiamenti pettorali. Accanto ai nomi, i luoghi, per lo più d’evasione (gite, fughe, transiti) o che incomprensibilmente, a ripensarci adesso, restavano nel perimetro della casa e del suo circondario.
B, sedili pullman
C, sedili pullman (stessa gita? A ricordarsene)
M, macchina e moto
W, scale d’emergenza
R, moto
G, moto
L, macchina
G, panchine villa
C, college (non ricordo dove, solo che puzzava d’hashish)
M, macchina
A, studentato
M, cepu
P, mensa rai
G, studentato
C, casa (mia)
Qualcuno potrei averlo effettivamente perso, sta di fatto che da qui in poi il catalogo si sdoppia: è cominciata la fase dépense del mio apprendistato sessuale, di cui dirò. Per ora, il catalogo è questo:
M, casa (sua)
A, macchina
F, sala dottorandi
P, bordo scrivania
L, mare
P, campus
S, gommone
S, museo
D, casa (mia)
D, hotel
T, pavimento casa editrice (così un giorno potrai dire che sei entrata in X)
O, scannatoio
M, divano
A, hotel
P, macchina
R, casa (sua)
P, casa (mia, al buio)
A, casa (sua)
G, androne
L, non mi ricordo

E no, non v’impiccate con l’à clef, le lettere sono casuali, inventate (fossi matta). Dunque ho limonato una dozzina di persone, e ho scopato con una ventina. Tutto qua? Beh, pochissimo non è. Per una che in fondo è frigida. Non mi sono mai masturbata senza l’ostacolo delle mutandine, per dire. E sempre guardando la stessa scena: Juliette Binoche strusciata sul lavandino da Jeremy Irons nel Danno. Una volta si trovava facile su Youtube adesso l’hanno levata, ma l’ho vista tante di quelle volte che la richiamo facile, alla bisogna. Il dramma qual era? Che tutti quelli con cui mi fidanzavo avevano problemi erettili o complessi di inferiorità di qualche tipo, eiaculazione precoce per lo più, cialis in tasca quantomeno. E poi madri-fidanzate come l’Annina caproniana, padri morti o troppo presenti, illegittimità di nascita, rivalità edipiche eclatanti, lotte interne, analisi decennale oppure incaponiti nel negarsi a ogni presa d’atto. Così il tradimento era quella balugine sessuale che in ogni singola storia certificata solveva la continuità, cioè la mortificante, insoddisfacente, talvolta umiliante ritualità monogama. C’era qualcosa di irresistibilmente virile nella casualità e nella distanza abissale da me di questi occasionali (il maestro di tennis, lo studente fuoricorso, il bestsellerista, l’editore erotomane, il bidello del cepu). Era quel disallineamento neurale, la chiave: se sono io, la dominante, compenso l’inefficienza sessuale, viene meglio. Meglio, ma mai soddisfacente a tal punto: devo simulare orgasmi che non proverò mai. Nel senso che magari qualche volta sarà anche successo, ma succede sempre dopo, oltre, quando non ne ho già più voglia. Il rapporto sessuale non esiste (thnks mr Lacan), e se esiste è nell’istante di penetrazione, cioè di rottura, di intrusione, invasione, pressione, ritrazione, ripulsa. Va bene di bocca, ma mi stufo presto, attiva e passiva. Sogno un sesso che non vorrei praticare, violento, umiliante, quello che pratico è pura estenuazione, ne scrivo, e bon.
La fama era perciò di allumeuse (per i non francofoni: profumiera). Tanto che L s’incaricò di ammaestrarmi, a un certo punto della nostra conoscenza fino a quel momento pudicamente lavorativa: io non ti giudico, Giada, se vuoi usare la seduzione per fare carriera, non ti condanno, ma così, no.
Così come? Per me funzionava al contrario. Che proprio non ci pensassi al corpo come strumento di carriera e che anzi mi negassi proprio agli occasionali più utili allo scopo. Però ci andavo a cena, certamente, perché no. Ci uscivo vestita bene, truccata, in gonna corta, perché no. Accettavo di essere accompagnata a casa in macchina, o finanche che mi pagassero il taxi del ritorno, WHY NOT se non avevo un euro in tasca. Li raggiungevo in hotel per colazione, in case che affittavano per incontri extraconiugali, ma solo per parlare, perché no. Non c’era strategia, pianificazione, obiettivi perseguiti, futuro, progettualità: solo simpatie abbastanza inquietanti, a ripensarci.

Quel che più mi rammaricava era essermi persa almeno 15 anni di sesso, dai 13 (in cui le mie più accessoriate coetanee più o meno tutte praticavano) ai 27 (stupore dell’analista, quando glielo racconto: ma proprio 27? Sì, mese in più, mese in meno): dovevo recuperare, riguadagnare terreno sulle altre. E, soprattutto, riscattare gli anni in cui la mia vita si era letteralmente fermata, come si fa con la pensione per quelli di studio. Che colpa ne avevo se la madre (la mia, certo) si era ammalata? E dopo di lei anche il padre (mio, di nuovo). Era una colpa se gli unici uomini con cui ero entrata in relazione quotidiana per mesi, e poi da mesi si erano fatti anni, indossavano camici verdi, avevano pesanti catene d’oro al collo, facce abbronzate ed erano evasivi, imprendibili, perciò sensualissimi, oppure ci litigavo? Tutti questi uomini diventarono un medico letterario: quando il padre morì, uscì il primo romanzo (mio, e di chi?) e tutti dissero che era pruriginoso, cattivo, violento. Io dicevo che non era un romanzo, perché dire romanzo, così avevo capito da L, voleva dire evasione, intrattenimento, e io non volevo proprio intrattenere nessuno, e anzi. Tutti dovevano soffrire, patire quello che avevo patito io. Quando il padre si era pisciato in ospedale e le infermiere lo avevano messo a verbale, paziente pisciato sotto, ridendo. O quando madre volle offrire un caffè all’infermiera e quella le gridò davanti a tutti ch’era ‘na terrona (ripetuto). O quando l’oncologa aveva chiesto di falsificare i referti del laboratorio e l’altra in cui al padre era caduta la minestra di bocca, ormai più cadavere che. Tutti dovevano sapere una cosa sola: che stavo male. Stavo così male che volevo stare bene cocciutamente, fare le presentazioni del non-romanzo, andare ai festival, parlare sempre in terza persona di tutto, la morte della madre, la morte del padre, così nessuno avrebbe detto che speculavo sul dolore e potevo restare nel recinto accreditato della Letteratura che piaceva ai miei amici critici, odiatori dell’intrattenimento e del midcult. Il midcult lo facevano le scrittrici, le femmine, tipicamente, e io parlavo di me al maschile: sono uno scrittore, un critico. Io non leggevo né Jane Austen e i suoi matrimoni né Elena Ferrante e le sue paesane redente. Io avevo visto la morte in faccia, non si dovevano paragonare. Quando chiesi a P, fidanzato in pectore, se mi portava al mare, mi guardò come fossi una pietra: non ero a lutto, non dovevo crogiolarmi nel dolore, magari a letto? A volte mi svegliavo e cominciavo a strusciarmi sulla sua gamba: il dolore lo fa, di esacerbare. Era sempre più sconvolto, più interdetto da quell’eccitazione di vita a poche ore dalla morte. Al funerale aveva camminato all’indietro per non dare le spalle alla bara. La zia disse che non era bello, ma aveva delle belle camicie inamidate, P. Io riuscivo a pensare solo a R, il maestro di tennis, a quando lo avrei rivisto, a quanto avrei goduto tra le sue braccia. Aveva il cazzo piccolo, da quel che ricordo, ma come nella leggenda di cui prima di allora mai avevo avuto prova (né necessità della medesima) le dimensioni non contavano e anzi, favorivano il godimento perché non c’era attrito, spinta, foga ma dolcezza carezzevole, un moto che somigliava al solletico delle prime stimolazioni involontarie durante gli esercizi di ginnastica alle medie. Una lagna, R. fuori dal letto. Chiedeva cose che quando mai nella vita, la vita è una cacca che vai pestando continuamente, e quello che puoi fare è provare a pulirti le suole o passare a un altro paio di scarpe. E così fu, per entrambi. Non prima di aver visto morire la madre (io) e di sprofondare nell’abisso della depressione durante una vacanza a Londra (lui). Dopo che cosa ne è stato, della speranza di godere con un altro corpo? Mulinelli di esperienze che non costruivano storie, figurarci memorie. Volti smangiati, affanni dissipatori e logoranti, le eterne, infinitesimali galoppate. Il bestsellerista nel loculo con buio di tomba, andargli a occupare la casella ics del suo, di catalogo, per nessun piacere in cambio e un po’ di HPV (per fortuna CIN1, estirpabile con 400 euro di conizzazione). Che cos’è, il piacere, Giada? Ah boh. Non l’ho mai sperimentato. Non è di questo mondo, probabilmente, meno ancora nello spazio dell’intelletto e del sé consapevole. Per l’intellettuale il piacere è la conquista, l’idea di Giada, per gli ottentotti inanellare fiche o cazzi, pensarsi in una serie riproduttiva senza il vincolo animale dell’ingravidamento: non è per figliare, che ci accoppiamo, e piuttosto il contrario. Ci accoppiamo coi giovani, che non vogliono perché è presto, coi vecchi, che non possono perché è tardi, cerchiamo nella discrasia e nello scivolamento discreto l’unico possibile culmine, via da quella stanza, adesso, non vorrai mica un po’ d’affetto o magari dormire con me. Dormire è consegnarsi, con i ronfi i peti i fiati. Per carità, ci vuole moltissimo amore. Amore, e anosmia.