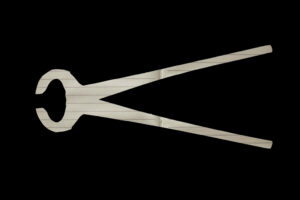Sono a cena in un ristorante thailandese, a Parigi, con B. e M. Vivono entrambi qui da trent’anni: lei insegna filosofia, lui letteratura. Ordiniamo. B. parla un francese pulito per lessico e sintassi, ma conserva con tranquillità un marcato accento italiano: nasalizzazioni assenti, erre appena arrotata, linea melodica della frase in cui si percepisce ancora la linea delle nostre frasi. M., invece, il francese lo canta: mi chiedo se i parigini percepiscano in lui l’origine straniera, e ne dubito. Anzi, quando attacca a parlare italiano, è il rovescio di B.: i suoi e dunque sono degli et donc traslitterati, le frasi prendono una piega che suona strana, le interiezioni sono bon, ouf o bof, anziché vabbè, seee o bah. Anche il tono è diverso: B. ha una voce chiara, alta, è un carnevale di segni soprasegmentali, che variano imprevedibili e ribelli; M. parla basso, fa una musica di pochi accenti, dà all’intelligenza un vestito sonoro castigato, modesto, ironico. Mi chiedo le ragioni di questa diversità, che non ha a che fare con le competenze linguistiche, in realtà quasi identiche, ma con un intero atteggiamento di fronte a un mondo in cui vivono da quando avevano entrambi vent’anni, in cui sono perfettamente inseriti, ma in cui B. mostra senza scrupolo, e senza esibizionismi, la propria alterità, ed M. invece è riuscito a camuffarsi perfettamente. Già, perché anche nel modo di vestirsi ha qualcosa di non italiano: chi di noi, con questo freddo, andrebbe in giro in giacca di velluto e pullover? Chi userebbe il cappello come un accessorio di lusso pleonastico, anziché rinserrarsi nel cappuccio di una giacca a vento per scongiurare sinusite o mal d’orecchi? B. è perfettamente a suo agio con la propria imperfezione; M., a pensarci, sembra peccare persino di ipercorrettismo, a tratti, e sia pure con garbo, sembra più francese dei francesi, sembra un italiano che recita, perfettamente, la parte del francese. Lo guardo, mentre B., come al solito, fa schizzare gocce di zuppa bollente e chicchi di riso sulla tovaglia e sulla gonna; e mi rendo conto dall’eleganza con cui tiene i gomiti aderenti al busto o passa da un interlocutore all’altro che c’è in lui non lo sforzo, ma un’abitudine così inveterata al controllo, che si sarà dimenticato cosa deve tenere sotto controllo. Tra loro due non c’è differenza di classe: sono entrambi buoni borghesi, lei viene da Bologna, è figlia di un magistrato importante e di una chimica analitica che ha diretto il suo dipartimento, lui, bresciano, di un neurologo dal quale andavano in pellegrinaggio da tutta Italia e di una professoressa di latino e greco che sembrava abbinare i suoi foulard Hermès, scelti con sobrietà studiata, al dorso degli Adelphi che decoravano a distesa le librerie di casa. Ma a un certo punto, mentre li osservo e parliamo dei nostri compagni di università variamente dispersi o variamente arrivati in cattedre di mezzo mondo, uno a Roma, l’altro a Berkeley, mi viene in mente F., che è diventato regista, e che da un anno all’altro, dal nulla, era capace di iniziare a parlare spagnolo come un madrileno, francese con la stessa sicurezza, e un po’ di civetteria in più, di M. M. ed F., del resto, condividono qualcos’altro oltre alla disinvoltura con cui hanno appreso lingue e modi di fare (per loro, gli spaghetti o la mozzarella sono diventati esotici come il pad thai che ho io ora fra le mie bacchette): sono entrambi gay. Non ricordo quale dei nostri amici sostenesse che i gay sono particolarmente portati per le lingue, sanno con più destrezza imparare idiomatismi e riprodurre suoni o cadenze perché hanno bisogno di confondersi con gli altri, al pari di certi animali poco veloci o non abbastanza forti che hanno sviluppato uno speciale mimetismo e che però, proprio mentre vorrebbero cancellarsi sulle distese di sabbia, contro le cortecce screziate o tra le foglie dei rami, si tradiscono per gli occhi troppo sporgenti e globosi, la lingua bifida e azzurra, le zampe munite di ventose circolari, callose.

I gay, diceva, spingono così in là il loro conformismo da cadere sempre in qualche esagerazione incongrua, si lanciano in virtuosismi che approdano allo sdilinquimento del gesto troppo artefatto o alla stecca di una nota troppo acuta e fuori della loro estensione. Naturalmente, l’amico veniva ogni volta sommerso dalle contumelie: l’avevano respinto subito nel mucchio di quelli che dicono che i gay sono sensibili o hanno gusto e sono versati nella moda e nelle arti (ma più nella moda), trasferendo sull’orientamento sessuale quel gruzzolo di luoghi comuni da quattro soldi che i poveracci applicano alle identità locali (i genovesi sono tirchi, gli spagnoli calienti). Facevano bene a prendersela con lui, per carità. Le eccezioni si sprecano: il mio francese, tanto per dire, è passabile, il mio inglese inverecondo. Le generalizzazioni hanno sempre torto, la pluralità dei casi singoli sta sempre lì a sbeffeggiare l’arroganza classificatoria del pensiero. Eppure, e però… A guardare M., a ricordare F. che tornato da New York dove era stato meno di un mese citava street e avenue per numero ordinale come se li vedesse e fossero farfalle spillate in un espositore, con le loro forme e i colori che rendono impossibile confonderle, l’idea che in noi gay ci sia o ci possa essere una vocazione mimetica particolarmente spiccata, un bisogno di fare come gli altri, specie se gli altri sono altri per noi tutti, cioè, appunto, stranieri; un bisogno, insomma, di cancellarci, e insieme una protesta di eccezionalità che ci fa ribellare a qualunque regola, persino quelle che ci siamo imposti per amore di distinzione, non mi sembra poi così lontana dalla verità.
M. racconta aneddoti buffi sulla sua mancanza di senso dell’orientamento: prende la metro nella direzione sbagliata, sbuca in banlieue dove beurs in canotta lo guardano irridenti, gonfiano i muscoli tappezzati di tatuaggi mentre li avvolge una nuvola di… come si dice in italiano? ah, oui (aspira, come fanno i parigini), maria. Ha diretto per anni un centro di ricerca che gestiva svariate migliaia di euro, so che è affidabile e corretto senza cadere vittima né di quelle ossessioni burocratiche che ingombrano la testa di certi miei colleghi, né della spocchia ridicola di chi crede di avere «una posizione», peggio se «di prestigio». Gli ho sempre voluto bene anche per questo suo bisogno di correggere la sua immagine con un understatement istintivo, che mette insieme virtù estetiche o (ma in questo caso non c’è differenza) morali, e il timore infantile, incancellabile persino ora che è un cinquantenne di fama, di essere smascherato nella sua debolezza – che poi, è quella. Forse alla fine la volontà di negarci è la sola cosa che ci salvi, e tanto meglio se siamo le copie riviste di altri, di altro, se alla fine, perdendoci, riusciamo a comportarci come se fossimo stranieri a noi stessi.