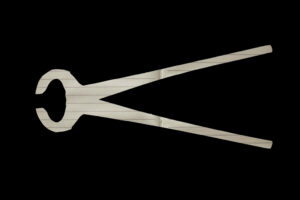La muta infantile che cerca gli animali tra le buche d’acqua e le dune del cantiere aprendo le rane per la curiosità di vedere la fatica che fanno per rimanere vive, gli organi che si muovono da soli nell’addome, gli occhi che restano aperti a guardare noi, nei pomeriggi che in futuro sembreranno pezzi di un mondo anteriore dove tutto esisteva frontalmente, senza le velature che ogni cosa avrà sempre poi, fino a quando lo sbalzo di umore, la noia, il primo scroscio ci riportano a casa dalle madri e liberiamo i prigionieri, li ributtiamo in acqua a agonizzare.
Rossini che ha paura dei treni e dei battelli a vapore, dei teatri e delle folle che scendono in strada durante il carnevale o la rivoluzione; Rossini che smette di scrivere musica prima dei quarant’anni mentre il pubblico lo celebra e lui cena con Metternich e tre o quattro principi dell’Europa restaurata, lui che ascolta Beethoven accorgendosi di essere mediocre e condannato, un vieux rococo, una forza del passato; e allora si sfascia, mangia per sopraffare l’umor nero e il panico odiando il romanticismo, evitando i treni (“un altro nel mio stato si ammazzerebbe, ma io sono un vile e non ho il coraggio”), però è ricco e celebrato, l’ironia lo fodera e gli impedisce di vedere, o forse lo porta più in alto sopra il suo nulla, il mio nulla, la sua musica di merda, i dubbi sulle mie poesie; quando passeggia alle Tuileries lo riconoscono, i suoi ritratti si vendono come le immagini sacre o i poster delle star; Napoleone III che lo invita nel suo palco e gli dice di sedersi senza aspettare che lo faccia prima lui, l’imperatore, “tanto tra noi regnanti l’etichetta non conta”; il giovane Wagner che in fondo lo disprezza, ma aspira comunque a esser ricevuto da lui come un tempo lui, Rossini, era andato a cercare Beethoven a Vienna; Rossini che a poco a poco si accetta e si rassegna e ricomincia a scrivere per sé e per Olympe, che a quindici anni era stata venduta dalla madre a un duca e poi era diventata una cocotte, amante di Sue, amante di Balzac, ma Rossini l’ha sposata e le ha permesso di avere il più importante salotto colto di Parigi, e ora lei lo accudisce come il figlio che non ha avuto, come il capitale che non ha.
L’angoscia che ti procurano gli altri quando ti fanno scivolare in una vita interstiziale piena di fantasmi, differenze di opinione, grandi nuvole di implicito che aleggiano sopra le conversazioni nascondendone il motivo, ma anche l’irrealismo di questo motivo quando si rivela e mostra, di riflesso, il bisogno che hai di restare nel tepore del non detto, nel guscio delle mezze parole ora che devi discutere o mangiare insieme a questi alieni, perché è l’indifferenza che tiene insieme le persone nel grande spazio opaco dove nessuno sa chi sei, e in fondo ti va bene, in fondo non importa.

Collins che resta a orbitare sul Columbia mentre Armstrong e Aldrin scendono verso la Luna e lui li fotografa con la Terra sullo sfondo, in un’immagine che contiene l’umanità presente, passata e futura, tutti i vivi e i morti tranne lui, Collins, che parla con la radio e cerca conforto a Houston, fino a quando la massa della Luna si interpone tra lui e la Terra tagliando il collegamento e lasciandolo solo come nessun altro essere umano è mai stato tranne i sepolti vivi, lui che pur di non essere scartato aveva nascosto la claustrofobia negli addestramenti, e ora sa di dover controllare il panico per i quarantotto minuti del silenzio-radio senza un aiuto o un’altra mente umana, volando come in una bara sul lato oscuro della Luna, mentre Armstrong e Aldrin vanno verso la superficie che lui non toccherà mai; Collins, il terzo astronauta, quello che pochi conoscono, quello che non è mai stato veramente sulla Luna, come gli verrà ricordato in tutte le interviste del futuro, quello che se anche riuscisse a ritornare sulla Terra sa che dovrà vivere il tempo che gli resta in funzione di ciò che accade ora, perché qualunque cosa succeda la sua vita finisce adesso, o per asfissia in questa capsula (Armstrong e Collins partirono pensando di avere una possibilità su due di ritornare, Aldrin una su tre) o con un momento di gloria apicale, secondario rispetto a quello di Armstrong ma comunque irripetibile, che renderà irrilevante qualunque cosa gli accada in futuro e lo farà vivere di rendita e rimpianti, sperimentando la pena di coloro che esistono al passato (gli ex-calciatori, le attrici che sopravvivono a se stesse per anni dopo la fine di tutto, le facce e i corpi deformati, raccontando ciò che sono state tra i colori pastello delle televisioni pomeridiane), Collins mentre attenua la luce della cabina per guardare i crateri che nessuno ha mai guardato, cercando di far passare i minuti che mancano alla fine dell’orbita e al ritorno della radio. Parlavo della possibilità che lei morisse, della paura, della non-paura che questa idea mi suscita, come se non appartenessi mai veramente, come se non amassi mai qualcosa per intero, ma il discorso slittava sui corpi e sui piedi, sull’orrore di una stagione che tra poco si riempirà di corpi e di piedi, su come possa venire in mente di aggredire gli altri con una cosa così intima e lurida e che vi dipingete pure, come dei selvaggi, la paura di essere invaso o vivo o solo in mezzo a chi non c’è sempre stato, e qui siamo arrivati a Collins che ruota attorno alla Luna nel suo orrore senza radio e poi di nuovo ai piedi, ma l’ora era finita e io dovevo alzarmi, pagare, ritornare in me.
R. che lavora al banco del pesce della Coop di Campi mentre la neoplasia gli cresce dentro senza che lui lo sappia. Di lì a qualche mese prenderà un giorno di ferie per venire al funerale di mio padre, ventitré anni dopo l’ultima volta che ci eravamo visti quando lui era andato al tecnico e io al liceo, e mi parlerà come se il passato avesse una presenza, ma non ce l’aveva e non ce l’ha, lo dicono i suoi tatuaggi e le mie maniere, le stesse che quattro anni dopo mi impediscono di saltare un consiglio, una riunione, un pranzo coi colleghi, una cazzata per andare al funerale, o anche solo per telefonare a sua madre, e che oggi mi permettono di parlarne in questa sede con tutto l’esibizionismo, con tutta la viltà che mi appartiene.
Ho abbracciato l’alba d’estate. Nulla si muoveva ancora sulla fronte dei palazzi, l’acqua era morta, i campi d’ombra non lasciavano la strada del bosco. Ho camminato risvegliando gli aliti vividi e tiepidi, e le pietre preziose guardarono, e le ali si alzarono senza rumore. La prima impresa fu, sul sentiero già pieno di bagliori freschi e pallidi, un fiore che mi disse il suo nome. Risi al wasserfall biondo che s’arruffò tra gli abeti, dalla cima argentata riconobbi la dea. Allora alzai i veli a uno a uno, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l’ho denunciata al gallo. Nella grande città fuggiva tra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle panchine di marmo io la incalzavo. In cima alla strada, vicino a un bosco d’allori, l’ho avvolta con i suoi veli ammassati e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L’alba e il ragazzo caddero giù nel bosco. Al risveglio era mezzogiorno.
I missili balistici che escono dai silos tracciando scie davanti ai camionisti in viaggio sulle autostrade del Montana o dell’Estonia mentre gli annunci sui cellulari e le sirene diffondono l’inebetimento o il panico, i missili che lasciano cadere i primi stadi nella stratosfera toccando la velocità di punta nello spazio privo d’aria, orientandosi con le stelle nel momento pacifico del volo, nella fase di crociera, quando attraversano l’Europa in sei minuti o cambiano continente in meno di mezz’ora, poi si apre la calotta, le testate cercano i bersagli mentre i missili russi o i missili cinesi percorrono la rotta inversa, le ogive finte per ingannare le difese, i megatoni sopra le città.