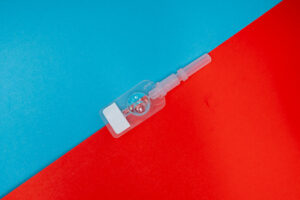Ci sono prodotti culturali che toccano le corde giuste dell’opinione pubblica, producendo riverberi destinati ad alimentare settimane di discorsi e momenti di confronto: di solito accade a provocazioni ad alzo zero, arruffianamenti su pellicola o su carta, calcoli di marketing precisi al millimetro o storie sospinte dal vento della cronaca o degli algoritmi. Ma qualche volta, molto più raramente, un’opera autoriale riesce ancora a ritagliarsi uno spazio perché ha qualcosa di interessante da dire. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda American Fiction, il debutto alla regia di Cord Jefferson (Watchmen, Master of None), che gli è appena valso un Oscar alla Migliore sceneggiatura non originale e un posto da protagonista nel parterre della critica socio-culturale dei nostri tempi.
Il film è tratto da Erasure (in italiano Cancellazione, La nave di Teseo, trad. di Marco Bosonetto) del romanziere Percival Everett, e come Erasure racconta la storia di Thelonious ‘Monk’ Ellison, scrittore e professore universitario di mezza età proveniente da una benestante famiglia afroamericana del New England che non riesce a conformarsi a un’identità che gli è imposta dall’esterno. A voler essere cattivi, si potrebbe dire che le parti combacianti tra romanzo e trasposizione cinematografica non finiscono qui, ma quasi.
In ogni caso, Monk scrive romanzi ispirati alle tragedie greche e vive un momento di particolare crisi: le vendite sono ai minimi, il jet set dell’editoria non lo calcola, il suo agente gli dice chiaro e tondo che il mercato da lui vuole “un libro nero”, nel senso di intriso di Blackness, di appartenenza identitaria standardizzata, e lui risponde tra l’incredulo e il piccato: «Il mio è un libro nero perché sono nero e l’ho scritto io» (primo di una serie di applausi abbozzati di fronte al televisore).
Senonché poi, con poco serio e molto faceto, ne scrive uno “nero” nell’altro senso: l’autobiografia di “Stagg R. Leigh”, alter ego del ghetto in fuga dalla polizia che racconta la sua storia, ehm, “vera” di latitante in bilico tra l’illegalità e la sopravvivenza svantaggiata. Monk lo manda al suo agente, che lo convince a inviarlo a una casa editrice con le scrivanie in vetro e i divani in pelle a Manhattan. La casa editrice, ovviamente, ci vede una gallina dalle uova d’oro, gli offre un anticipo principesco e lo pubblica, rendendolo un bestseller. Ah, l’opera in questione si intitola prima My Pafology, facendo un verso grottesco al gergo afroamericano, e poi – quando l’autore si decide a provare il tutto per tutto e testare il limite della sua gag – direttamente Fuck.
American Fiction è un film stimolante, acuto, con un Jeffrey Wright nei panni del protagonista che, fossi un critico cinematografico, definirei con una di quelle espressioni tipo “in stato di grazia” e diversi interrogativi ben posti. Ed è per questo motivo che trovarne i difetti a prima vista potrebbe sembrare un esercizio pedante o, peggio, da bastian contrario in servizio permanente. Ma non lo è, proprio perché la pellicola aveva le basi per fare benissimo e ha fatto, globalmente, poco più che benino.

Senza arrivare a macchiarsi del reato di spoiler, il più grave di quest’epoca, basti dire che Monk alla fine – nel film come nel libro – si troverà messo con le spalle al muro nel suo tentativo di sfuggire a un conformismo sistemico da cui risulta impossibile evadere. In Erasure, tuttavia, la parte di satira sociale e culturale era molto più sviluppata: vi si leggono dieci capitoli di Fuck, tanto per dire, comprensivi di banalità sesquipedali e descrizioni macchiettistiche da fumettone della vita nel ghetto, oltre che approfondimenti taglienti sull’accoglienza della finta biografia da parte dell’establishment editoriale bianco, con una critica ridicolmente entusiasta e interviste tra lo sdraiato e il pretesco. American Fiction, viceversa, vira decisamente verso la vita personale di Monk, che nel giro di poco tempo perde la sorella per un malore improvviso e vede ammalarsi di Alzheimer la madre: una scelta legittima, ma che depotenzia l’impianto di critica culturale del film, rendendolo poco più che una serie di scenette (alcune memorabili, come la prima telefonata di “Stagg R. Leigh” alla casa editrice, in cui Monk si trova costretto a imitare una parlata jive stereotipata per vendere il personaggio – secondo accenno di applauso – altre meno).
Senza contare che c’è un problema di scarto temporale nell’adattamento. Erasure è uscito nel 2001, a dieci giorni di distanza dall’11 settembre, in un mondo radicalmente diverso per l’editoria statunitense e per tutto il resto: libri come We’s Lives In Da Ghetto, il successo della giovane e ruffiana autrice Sintara Golden che funesta l’integrità professionale di Monk, non esistono quasi più (e, quando esistono, non sono casi editoriali da almeno una decina d’anni).
L’impressione è che, al di là della sua pregevolissima fattura, American Fiction tenga il freno a mano tirato e non esplori le strade che ha il merito di tracciare davanti a sé: quando Golden e Monk si incontrano in una pausa di lavoro della giuria letteraria di cui fanno parte, lei fa il contropelo alle timorate accuse di lui, spiegandogli che se il viatico del successo è scrivere per lisciare il pelo del pubblico non è colpa sua, che ha dovuto farsi largo in un mainstream maschio e di etnia caucasica. Un buon argomento, ma a cui lo spettatore suppone che il protagonista sappia opporre qualcosa di più della scena muta che le offre in risposta: se Cord Jefferson con questa aggiunta – nel libro la scena non c’è – voleva ribaltare la prospettiva ci è riuscito, ma pagando il prezzo di confondere quella della sua opera.
American Fiction non è di certo il primo lungometraggio a portare in scena la frustrazione di un afroamericano incapace di rientrare nei ranghi della rappresentazione culturale stereotipata (tra i predecessori si possono citare, tra gli altri, Bamboozled di Spike Lee e Hollywood Shuffle di Robert Townsend), ma è il primo a farlo in anni in cui l’opinione pubblica globalizzata ha impresso su di sé espressioni onnipresenti come “cultura woke” e “dittatura del politicamente corretto”. Il risultato è brillante, ma abbastanza indeterminato da permettere a chiunque di proiettarci una sua opinione più che leggerci una critica articolata da qualcun altro. Come spiega il fedele benché cinico Arthur, l’agente di Monk, al suo assistito: «I bianchi credono di volere la verità, ma non la vogliono: vogliono sentirsi assolti». Di questi tempi, purtroppo, non sono nemmeno gli unici.