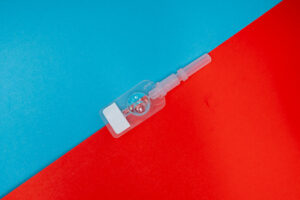Non sono mai riuscita a essere troppo severa con Chiara Ferragni, rendendomi conto fin dal suo emergere di quanto ciò che altri criticavano ci riguardasse intensamente a diverse altezze. La sua monetizzazione del privato su larga scala, quella miscela oscura tra racconto di sé istantaneo e ricostruzione rinarrata di un sé più bello e scintillante, quello strano scarto tra autenticità quotidiana e autenticità quotidiana rinarrata con sponsor annesso in dotazione, mi sono sempre parsi in un legame di oscura parentela con il mio passato di blogger, quando raccontavo i miei fatti sotto pseudonimo, con la mia vita sui social oggi, con i reality che non vedo ma di cui so, con la letteratura che invece acquisto, con le cronache di tutti i baci che una scrittrice ha dato, per fare un esempio, con la diaristica del mancato suicidio di un’altra, di memoir in memoir. Ferragni mi è sembrata il correlato modaiolo e remunerativo di una tendenza collettiva che rende la narrazione della propria esperienza soggettiva un oggetto di mercato relazionale ed economico: colei che ha portato alle estreme conseguenze una postura che a oggi è largamente condivisa, fino ad arrivare a fare operazioni che mi hanno lasciato interrogativi professionali, per esempio su come i figli decodificheranno il fatto di essere inscritti in questo circuito, o sul significato diagnostico – dopotutto sono una psicoterapeuta – che può avere il fatto di diffondere urbi et orbi stralci di una dolorosa psicoterapia, come ha fatto il marito Fedez.
Questo contenuto è visibile ai soli iscritti
Snaporaz è una rivista indipendente che retribuisce i suoi collaboratori. Per esistere ha bisogno del tuo contributo. Accedi per visualizzare l'articolo o sottoscrivi un piano Snaporaz.