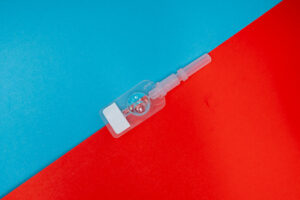Ogni epoca ha i suoi cantori: la prima Grecia classica traluceva nei patronimici degli aedi; la Rivoluzione francese trascolorava nei quadri di Jacques-Louis David e si nutriva del contrattualismo dei filosofi illuministi; l’America rurale degli anni a cavallo fra le due Guerre mondiali si riconosceva nelle ballate di Jimmie Rodgers. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo dei tizi che fanno le faccine e ci tengono incollati agli schermi attraverso i quali osserviamo le vite degli altri.
La prima occorrenza del termine influence risale al Seicento, quando si riferiva a ciò che allora era considerato il movimento delle sfere celesti – o “di influenza”, appunto – nella cosmologia di impianto tolemaico. Nella seconda metà del Settecento poteva a buon diritto definirsi influencer Josiah Wedgwood, uno dei volti cardine della Rivoluzione industriale, che reclamizzava le sue ceramiche come quelle del “vasaio di Sua Maestà” dopo aver venduto un set da tè a Buckingham Palace. Volgendo più velocemente fino all’Anno Domini 2010, l’influencer è diventato l’architrave della comunicazione pubblica globale: ha ancora ceramiche da piazzare, ma nel farlo ha iniziato a indirizzare il nostro lessico, la nostra logica e le nostre connessioni cognitive; in altre parole, la nostra cultura condivisa.
Nel 2023 il cosiddetto “influencer marketing” movimenta un giro d’affari stimato in più di ventuno miliardi di dollari
E un primo aspetto problematico (il termine, lo vedremo, non è casuale) è proprio questo: nell’era delle piattaforme a “influenzarci” sono persone che, fin troppo spesso, hanno qualcosa da venderci.
Questo contenuto è visibile ai soli iscritti
Snaporaz è una rivista indipendente che retribuisce i suoi collaboratori. Per esistere ha bisogno del tuo contributo. Accedi per visualizzare l'articolo o sottoscrivi un piano Snaporaz.