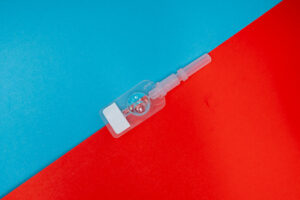Fin da quando, a diciassette anni, divoravo ripetutamente La prima notte di quiete di Valerio Zurlini, con Alain Delon nelle vesti di un professore di letteratura che s’innamora della sua allieva più cupa e malinconica, o da quando, negli anni dell’università, mi ritrovavo a consumare i film degli anni Settanta di Claude Sautet, innamorandomi ogni volta dell’immagine sgranata di Michel Piccoli e del suo corpo imperfetto, per poi cercarne una replica in quasi ogni uomo che incontravo, ecco, fin da quegli anni il cinema è sempre stato un riflesso, sebbene scomodo e spaventoso, all’epoca, di ciò che voleva dire per me desiderare.
Oggi ognuno manifesta a gran voce i propri desideri nella misura in cui sono legati alla costruzione di un’immagine di sé che non prevede la contraddizione né qualcosa che vada a opacizzare la “correttezza” di un’identità: costruiamo quest’ultima in un determinato modo perché è ciò che permetterà la sopravvivenza in un sistema in cui ci si deve proporre come personaggi, figure che incarnano ideali ben precisi. Queste riflessioni e quelle che seguono vogliono essere, invece, un tentativo di problematizzare, sulla base di quelli che definirei i miei protocolli di visione – come mi relaziono a un certo tipo di cinema – la natura sconveniente del desiderio e come quest’ultimo interagisce con una certa sensibilità politica e culturale.
Qualche tempo fa ho rivisto una sequenza che considero tra le più sensuali e destabilizzanti della storia del cinema. Il film è Le farò da padre (1974) di Alberto Lattuada
Questo contenuto è visibile ai soli iscritti
Snaporaz è una rivista indipendente che retribuisce i suoi collaboratori. Per esistere ha bisogno del tuo contributo. Accedi per visualizzare l'articolo o sottoscrivi un piano Snaporaz.