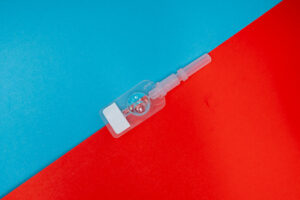In principio, era il maltempo: nelle forme rudimentali di attività imprenditoriale, se così vogliamo chiamare i primi commerci del Neolitico, la cosa peggiore che poteva capitarti era che qualche gelata fuori stagione ti privasse del grano con cui avresti potuto campare per l’intera stagione. Una seccatura, certo. Ma proseguiamo veloce fino a 2024 anni dopo la nascita di Gesù Cristo, e notiamo con sorpresa che oggi i più grandi rischi per il commercio sembrano venire da piattaforme intangibili dove le persone amano passare giornate intere a insultarsi dietro uno schermo.
L’Eurasia Group, influente società americana che opera nella consulenza dei rischi politici, ha diramato il suo rapporto sul business per l’anno appena iniziato: secondo Ian Bremmer, lo stimato fondatore del gruppo, la più grande minaccia per le aziende nel 2024 verrà dalle culture wars, quel complesso coacervo di polemiche virali, recriminazioni incrociate e strumentalizzazioni politiche che ha conquistato l’opinione pubblica americana e mondiale.
Secondo Bremmer, in un anno elettorale mai così polarizzato, per i business e i brand statunitensi la vera sfida sarà riuscire a camminare sulle uova delle insidie comunicative contemporanee, dove ogni campagna pubblicitaria è un potenziale passo falso nella direzione di un caso politicizzato o oggetto di shitstorm.
La casistica recente compone una lista fin troppo nutrita: ad aprile dell’anno scorso la destra americana si è rivoltata en masse contro l’innocua promozione della birra Bud Light da parte di un’influencer transgender di TikTok, Dylan Mulvaney, pensata per recuperare terreno nel segmento di clientela più giovane. Mulvaney si era limitata a promuovere il noto marchio con un video come tanti altri, ma il suo essere una donna trans aveva rapidamente trasformato la questione in “politica” – come l’aveva definita, tra gli altri, il cantante country Kid Rock – e aveva portato a un imponente boicottaggio di Bud Light, con cali delle vendite che hanno toccato il 26%. A un mese di distanza, Bud Light aveva perso il suo scettro di marca di birra più venduta negli Stati Uniti: una posizione che ricopriva da vent’anni.

Disney è caduta nella tela del ragno delle culture wars con più fragore di qualunque altro brand: più o meno negli stessi giorni in cui Bud Light navigava le acque della polarizzazione digitalizzata, la società di Mickey Mouse citava in giudizio il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, per aver orchestrato una «ritorsione politica contro l’azienda». Da oltre un anno la destra dello Stato si scontrava con l’azienda dopo il passaggio del disegno di legge ribattezzato dai media “Don’t Say Gay”, fortemente voluto dallo stesso DeSantis, che aveva proibito di parlare di orientamento sessuale e di identità di genere nelle scuole della Florida. Disney aveva dismesso le sue donazioni ai politici locali in segno di (tardiva) opposizione alla proposta legislativa, e ne era nata una schermaglia senza fine, passata anche per la decisione del governo di revocare lo status fiscale speciale di cui godeva l’imponente Disney World di Orlando.
Per le aziende non inciampare nelle guerre culturali è una missione impossibile, anche perché non di rado sono loro stesse a essersi messe in testa di poter camminare indenni su quel terreno: nel 2019 la Business Roundtable, un influente network di duecento amministratori delegati delle aziende più quotate d’America, è giunta alla conclusione che le loro compagnie dovevano fare più che semplice profitto, impegnandosi per migliorare le esistenze di clienti e comunità allargate. Un intento sicuramente lodevole, ma anche sincero? Nel suo saggio dedicato alla colonizzazione engagée dei board, Capitalismo woke (uscito in Italia per l’editore Fazi nel 2023), il professore di economia australiano Carl Rhodes argomenta che la svolta “attivista” dei capitani d’azienda sarebbe in realtà un modo di rendere più presentabili in società desideri di incremento dei ricavi vecchi come il mondo: Larry Fink, il capo del fondo BlackRock che proprio nel 2019 aveva parlato di una «società che si rivolge alle aziende per trovare soluzioni alle questioni sociali», auspicando un maggiore intervento diretto delle corporation nella vita dei cittadini, secondo Rhodes sarebbe stato in realtà terrorizzato dall’ipotesi di una malattia recidivante, o persino una morte improvvisa del sistema economico attuale, correndo ai ripari con una proposta di rebranding più fresca e catchy. «Lo scopo del capitalismo woke si rivela, dunque, quello di salvare il capitalismo stesso» si legge nel saggio: e allora più che di rischio d’impresa si tratta di questione di vita o di morte.
Il timore è che fuori dai Cda, dalle polemiche internettiane e dalle strumentalizzazioni di politicanti senza scrupoli, a fare le spese delle guerre culturali siano sempre più persone comuni vittime di divisioni ingigantite. Boicottare lo spot di un’influencer transgender è una cosa, ma vivere in una società fatta – per fortuna – di differenze e diversità è un’altra: e per riuscirci senza soccombere all’incomunicabilità interessata non basta un corso aziendale.