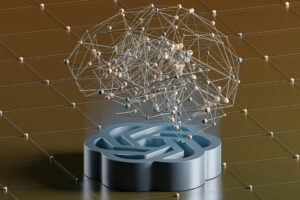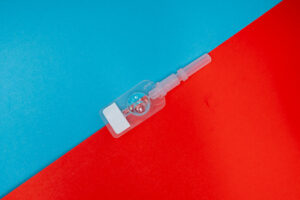[Questo intervento è il testo di una conferenza tenuta al Colegio Nacional di Città del Messico il 5 aprile 2024]
I.
Nel 1961, su «Tempi moderni», Italo Calvino pubblicava un saggio, La «belle époque» inaspettata, che comincia così:
Quindici anni fa prevedevamo tutto, tranne che una cosa: che il mondo sarebbe entrato in una fase di “belle époque”. C’è il boom economico, un’aria di cuccagna, ciascuno bada ai suoi interessi. Quella intransigente tensione ideale che ieri animava propositi e azioni (buone o cattive che fossero) di uomini di governo e intellettuali, ora ha ceduto il posto a un modo di parlare e agire più possibilista e utilitario. Tutti, apertamente o sotto sotto, sono convinti che questa cuccagna durerà chissà quanto, anzi (e questo è tipico di ogni “belle époque”) che non finirà mai. C’è sì la guerra fredda che non è finita, e continuano anche alcuni spargimenti di sangue locali, ma la gente che è al riparo li guarda come grandinate estive in un giorno di sole.
Chi era la “gente” di cui parla Calvino? Non era tutta la società italiana, perché non è vero che la cuccagna c’era per tutti allo stesso modo, in Italia e a maggior ragione altrove (del resto Calvino ne era consapevole se poco dopo scriveva “l’immagine della folla stracciata e affamata fuori dalla porta del festino fa proprio parte dell’iconografia classica della ‘belle époque’”); ma soprattutto non è vero che tutta la società nel 1961 badava ai propri interessi. All’inizio degli anni Sessanta la partecipazione politica era vivissima; la Storia esisteva ancora nel senso enfatico, maiuscolo del termine, avendo ancora la forma della grande guerra novecentesca che, nella prima metà del secolo, aveva contrapposto il liberalismo, il fascismo e il comunismo, cioè i tre modelli di società che avevano cercato di organizzare la vita delle masse prodotte dalla rivoluzione industriale e demografica moderna. Dal 1945, dopo la sconfitta del fascismo, i due modelli superstiti combattevano una guerra mondiale in forma fredda e l’Italia era sulla linea del fronte che separava l’Ovest dall’Est: alleata degli Stati Uniti, ospitava il più grande partito comunista dell’Europa occidentale, i militanti iscritti alle forze politiche erano milioni, l’appartenenza politica era per molti un fatto identitario. Di lì a pochi anni sarebbe cominciato il lungo Sessantotto, cioè il periodo di conflitto endemico che si apre alla fine del 1967 e si conclude all’inizio degli anni Ottanta, durante il quale il paese avrebbe vissuto quella che è stata chiamata la sua terza guerra civile novecentesca. La prima si era combattuta tra il 1918 e il 1922 e si era conclusa con la vittoria del fascismo; la seconda aveva contrapposto, tra il settembre del 1943 e l’aprile del 1945, nel Nord e nel Centro del paese, la Repubblica di Salò fascista a una Resistenza antifascista che accoglieva cattolici, liberali, socialisti e comunisti, e dalla quale sarebbe nata la Repubblica italiana fondata sulla Costituzione del 1948.
Dunque quel senso di riparo, distacco dalla politica ed “euforia del consumo” (così Calvino poco più avanti) vale, nel 1961, soprattutto per una parte della società italiana, quella che viveva bene nella Western way of life reinterpretata dalla Democrazia cristiana, e che esercitava senza trasporto il diritto moderno di partecipare alla politica. La parte opposta, quella che seguiva la politica con impegno, simpatizzando magari per il comunismo o per il socialismo, ha avuto una solidissima egemonia nella cultura italiana ma non ce l’ha mai avuta nella società. Oggi sappiamo che il punto di vista della maggioranza era l’unico realistico. Nel 1961 l’Italia era un paese a sovranità limitata, come del resto lo è adesso: oggi ospita circa 12.000 soldati americani e, si stima, almeno cento testate nucleari, sempre americane; sei decenni fa i numeri erano diversi ma la sostanza era la stessa. Se durante la Guerra fredda la sinistra avesse preso il potere per via rivoluzionaria o democratica, come sembrava possibile a metà degli anni Settanta, l’Italia avrebbe fatto la fine del Cile. E la dirigenza del Partito comunista italiano lo sapeva benissimo: tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre del 1973, subito dopo il colpo di Stato di Pinochet, Enrico Berlinguer pubblica, su «Rinascita», tre articoli di riflessione sui fatti cileni nei quali si dice esplicitamente che la via democratica al socialismo può passare solo da un’alleanza larga tra tutte le forze popolari, a cominciare dai cattolici. Era anche un modo per far capire agli americani che la sinistra italiana, se avesse vinto le elezioni come Allende, non avrebbe mai preteso di governare da sola.

II.
Otto anni dopo il saggio di Calvino, nel 1969, Richard Nixon, il suo vicepresidente Spiro Agnew e lo speechwriter Pat Buchanan mettono in giro un concetto politico che avrà fortuna, quello di silent majority. Nixon chiamava così coloro che, pur appoggiando la sua presidenza e la guerra del Vietnam, non prendevano la parola e non scendevano in piazza, come invece facevano le minoranze rumorose dei contestatori. La maggioranza silenziosa si esprime al momento delle elezioni scegliendo i propri rappresentanti, e poi delega e vive nel privato, mentre nella prima metà del Novecento le maggioranze avevano dovuto partecipare alla politica per forza, essendo state mobilitate in grandi guerre nazionali e ideologiche, di solito contro la propria volontà.
Quasi negli stessi anni, per descrivere la nuova umanità postbellica creata dalla società dei consumi, Pier Paolo Pasolini inventa l’idea, in seguito popolarissima, di “mutazione antropologica”. Definisce così il cambiamento che gli italiani (ma il discorso vale per gran parte dell’Europa occidentale) avevano subito nel dopoguerra. Le classi medie e le classi popolari sono cambiate, scrive Pasolini: la vecchia borghesia “clerico-fascista” è stata sostituita da una borghesia di tipo nuovo, edonista, disinibita e dedita al consumo di cose, esperienze, corpi, che ha attirato a sé i ceti popolari snaturandoli; una borghesia orale, potremmo dire in termini psicoanalitici – diversissima dalla borghesia anale, perbenista e religiosa descritta da Max Weber – che si schiera a favore del divorzio e dell’aborto andando contro la dottrina della Chiesa, e adotta i nuovi costumi neopagani che lo sviluppo del capitalismo ha reso possibile, ma continua a votare per la Democrazia cristiana, il partito d’ordine che garantisce l’adesione al blocco occidentale. La “gente” di Calvino è molto vicina alla nuova borghesia descritta qualche anno dopo da Pasolini: vuole la cuccagna, bada ai suoi interessi, si disinteressa alla politica e prova, scrive Calvino nella parte finale del saggio da cui siamo partiti, “l’euforia di poter finalmente sognare il consumo senza sentirsi in colpa”. Soggetto sociale egemone già nel 1961, lo diventa a maggior ragione dopo la fine del lungo Sessantotto italiano, e in modo clamoroso e definitivo dopo il 1989-1991, quando finisce la grande guerra ideologica del secondo Novecento e si apre un’epoca nuova nella quale il capitalismo è l’unico modello economico praticabile e la democrazia liberale si presenta come l’unico sistema politico possibile, giusto e universale. Un anno dopo la caduta dell’Unione Sovietica (e la fine del Partito comunista italiano, che nel febbraio del 1991 cambia nome) escono due saggi che rappresentano molto bene il clima politico di quella fase negli Stati Uniti e in Europa occidentale, La fine della storia e l’ultimo uomo di Francis Fukuyama e L’illusione della fine o Lo sciopero degli eventi di Jean Baudrillard. Mettono in giro due formule fortunate: per tutti gli anni Novanta si è discusso seriamente di fine della storia e di sciopero degli eventi. Il soggetto politico e sociale tipico di questa fase storica è la versione aggiornata della “gente” di cui parlava Calvino, della maggioranza silenziosa di Nixon e della nuova classe media di cui parlava Pasolini: disimpegnata, felice della Western way of life, individualista o familista, consumatrice, turistica, disinibita, postborghese, superficialmente policroma se vista da vicino e intimamente coesa se vista da lontano, a suo agio nel perimetro politico e morale definito dalle due frasi di Margaret Thatcher che hanno segnato un’epoca: There is no such thing as society e, soprattutto, There is no alternative. Il primo soggetto politico che, a partire dall’11 settembre 2001, ha sfidato apertamente la Western way of life in una guerra asimmetrica ed endemica, cioè il fondamentalismo islamico, non ha dubbi nel considerare la forma di vita occidentale come un’entità unitaria: il giornale inglese on line dell’Isis, «Dabiq», usava comunemente le formule Westerners e Western way of life; il gruppo jihadista che agisce nel Nord della Nigeria si chiama Boko Haram, che in lingua hausa significa “il vivere all’occidentale è un sacrilegio”, dove “il vivere all’occidentale” è un singolare collettivo. Oggi, in un contesto completamente diverso, Vladimir Putin contesta l’ordine politico e i valori delle democrazie liberali parlando di “Occidente collettivo”: ai suoi occhi le divisioni interne alle nostre società sono del tutto secondarie rispetto agli elementi che le tengono insieme.

III.
Da qualche tempo questo quadro si è sfaldato. Provando a semplificare come si conviene in una circostanza come questa, potremmo dire che sono successe tre cose: la sensazione di essere al riparo si sta dissolvendo, le maggioranze non sono più silenziose, e l’umanità che la mutazione antropologica pareva aver reso unitaria sembra essersi divisa secondo linee di faglia nuove.
1. La sensazione di non essere più al riparo (la sensazione, in altre parole, che la fine della storia sia a sua volta finita) ha cause economiche, demografiche, geopolitiche ed ecologiche. Le espongo in questo ordine perché questo è l’ordine di importanza secondo il quale vengono percepite.
La crisi del 2008 ha ricordato all’Europa occidentale che la sua posizione di privilegio non è eterna. Se a metà degli anni Novanta i paesi di ciò che all’epoca era il G7 continuavano a produrre ben oltre la metà del prodotto interno lordo planetario, oggi ne producono poco più di un terzo. Dalla crisi del 1973 in poi il numero degli occupati nei paesi occidentali ha cominciato a diminuire percentualmente, la disoccupazione è diventata un problema, i diritti sociali si stanno sfarinando a poco a poco. È un processo che si sviluppa lentamente, ma la tendenza generale è chiara. E anche se il Pil è cresciuto moltissimo rispetto al 1973, la distribuzione della ricchezza all’interno delle società europee è diventata più ineguale, seguendo una tendenza opposta a quella prevalente tra il 1945 e il 1973, quando invece le differenze tendevano a diminuire. Insomma, le classi popolari e parti consistenti delle classi medie degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale sono tra gli sconfitti della globalizzazione. Una sconfitta lenta, certo, che produce i propri effetti a poco a poco, ma tale sotto ogni punto di vista se è vero che diminuisce la ricchezza relativa, vengono meno le tutele e aumentano le diseguaglianze interne alle nazioni, mentre la ricchezza planetaria si redistribuisce tra le aree del mondo.
Un secondo aspetto è la crisi demografica. La popolazione europea è destinata a decrescere, sia in termini assoluti sia in termini relativi; l’Italia, in particolare, è un paese che invecchia e si spopola, e il declino demografico è il segno di un declino politico nelle gerarchie del mondo a venire. Allo stesso tempo masse ingenti di persone di etnie e culture diverse da quelle europee premono ai confini, e questa trasformazione è vissuta con inquietudine dalla maggioranza dell’opinione pubblica. Le teorie di estrema destra sulla grande sostituzione sono la versione fobica di un fenomeno reale di cui la sinistra tende a sottovalutare l’effetto sul sentimento primitivo di territorialità e sulla paura ancestrale del diverso. Uno dei libri che meglio ha raccontato quello che sta accadendo lo ha scritto un sociologo francese, Didier Eribon, allievo di Bourdieu e amico di Foucault. Si intitola Ritorno a Reims (2009) e racconta il ritorno dell’autore, professore universitario e militante della causa omosessuale, nella periferia operaia di Reims dove era nato e cresciuto. Il quartiere della sua infanzia, che negli anni Cinquanta e Sessanta votava compattamente per il Partito (il Partito per antonomasia, quello comunista), negli anni Ottanta e Novanta aveva cominciato a votare per il Front National, e questo per molte ragioni, tra cui la paura e il fastidio per l’arrivo di persone con un modo di vivere e una faccia differente. È un processo che si è ripetuto quasi ovunque in Europa occidentale. E se oggi è evidente che una nazione in crisi demografica come l’Italia avrebbe bisogno di popolazione e forza-lavoro, cioè di immigrati, per mantenere una crescita economica sostenuta e un sistema previdenziale decoroso, è altrettanto evidente che questo bisogno razionale si scontra con resistenze profonde che nessuna forza politica ha il coraggio di sfidare davvero.
Un terzo aspetto è la disgregazione dell’ordine mondiale a egemonia americana che si era creato dopo il 1989-1991. La guerra in Ucraina ha aperto una fase nuova mostrando che gli Stati Uniti si sono indeboliti e che hanno meno voglia di occuparsi dell’Europa. Le maggioranze silenziose europee avevano accettato di buon grado la soggezione agli Stati Uniti che la nascita della Nato settantacinque anni fa, nell’aprile del 1949, aveva sancito. Gli americani garantivano protezione a paesi che di fatto rinunciavano (o erano costretti a rinunciare, essendo stati sconfitti in guerra) alla propria sovranità in politica estera; in cambio questi paesi potevano disinteressarsi di macropolitica e dedicarsi all’economia. Oggi le nazioni europee hanno eserciti sottodimensionati rispetto alla ricchezza che posseggono: solo la Francia e la Gran Bretagna hanno l’arma atomica; Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio ospitano armi nucleari americane, come gli Stati satellite che di fatto sono. La guerra in Ucraina ha ricordato agli europei che il riparo geopolitico nel quale vivono potrebbe finire, e più in generale ha ricordato, dopo quasi ottant’anni di vita in tempo di pace, che le guerre esistono, che la guerra è una possibilità della politica. Negare che sia così è un’illusione da anime belle e un segno di infantilismo politico.
Un quarto aspetto è la crisi ecologica, che tutti sappiamo essere reale, imminente e forse apocalittica. Ma se vogliamo dire la verità, dobbiamo riconoscere che di questa crisi, per adesso, non importa nulla a nessuno: la priorità vera del dibattito pubblico in Europa non è mai l’ecologia, e questo è vero in ogni paese, anche in quelli dell’Europa settentrionale. Dovrà passare almeno una generazione perché la crisi ambientale possa decidere le sorti di un’elezione, e non è affatto scontato che quel momento arrivi, perché le democrazie, che vivono nel presente eterno del consenso, faticano a pensare al futuro. Ciò detto, da tempo l’apocalisse ambientale è entrata a far parte dell’immaginario diffuso, le nostre serie televisive parlano di questo, giustamente, e ciò contribuisce non poco alla sensazione di non essere più al riparo.

2. Le maggioranze non sono più silenziose: hanno preso la parola attraverso i social network mettendosi al passo con le minoranze rumorose, e questo ha cambiato per sempre la logica della sfera pubblica. Se l’ethos della gente di Calvino — individualistico, postpolitico, nemico dell’impegno — è sembrato a lungo dominante tra le masse occidentali segnate dall’indebolimento dei legami e dall’atomismo sociale, il mondo delle nuove maggioranze rumorose sembra diverso da questo, almeno sul piano della comunicazione e dell’autorappresentazione. È uno spazio nel quale molti prendono la parola ogni giorno in una sorta di perenne assemblea on line divisa in bolle, come in bolle sono divisi i social network. In questo senso è interessante che la forma di aggregazione originaria del Movimento 5 Stelle fosse proprio l’assemblea on line.
Ora, esiste un legame organico tra questa nuova sfera pubblica e due fenomeni tipici della politica contemporanea: le guerre culturali e i populismi. Sotto certi aspetti potrebbero sembrare fenomeni opposti: le guerre culturali nascono dall’attivismo woke, che rappresenta l’equivalente contemporaneo delle vecchie minoranze rumorose, mentre il populismo così come si manifesta in Europa e negli Stati Uniti è generalmente di destra — anche se non sono mancati populismi che rifiutavano l’antitesi tra destra e sinistra (il Movimento 5 Stelle in Italia) o populismi di sinistra (Podemos in Spagna). La wokeness tende a essere cosmopolita, legata a quella parte delle classi medie che beneficia della globalizzazione, ama lo sradicamento, si comporta come un’avanguardia della metamorfosi dei costumi, mentre la base sociale dei populismi di destra è in continuità con le vecchie maggioranze silenziose e col loro ethos territoriale e patriarcale. La differenza col passato è che questo soggetto politico non è più silenzioso, sia perché, non sentendosi al riparo, prova paura e rancore, sia perché non ha più lo stesso rapporto con la rappresentanza politica e con la presa di parola.
Nel 2017, dopo la Brexit e dopo la vittoria di Trump, esce in Germania un volume collettivo intitolato La grande regressione, cui partecipano, tra gli altri, Arjun Appadurai, Zygmunt Bauman, Nancy Fraser, Eva Illouz, Bruno Latour, Wolfgang Streeck e Slavoj Žižek. Il tema al centro del discorso, quello che poi dà il titolo al libro, è il regresso di civiltà di cui i populismi di destra sono segno e sintomo. Il progetto illuministico di far uscire gli uomini dalla minorità sta perdendo terreno e la regressione più vistosa ha avuto luogo dopo la crisi del 2008, quando idee autoritarie, razziste e xenofobe che si ritenevano ormai indicibili sono riemerse nel dibattito politico, in molti casi facendo vincere le elezioni ai partiti che le sostenevano, come se l’ingentilimento dei costumi e la diffusione dell’Illuminismo tra le masse, che parevano uno dei risultati acquisiti per sempre nelle società occidentali del secondo dopoguerra, fossero ritornati incerti. Tutto questo suscita molte riflessioni. La prima è che la ragione per la quale la Western way of life ha imposto la propria egemonia nella seconda metà del XX secolo non è il suo presunto legame con l’idea illuministica di emancipazione o con la democrazia, ma la capacità di immergere gli individui in piccole bolle private di benessere e di autonomia: quando il benessere declina, l’incivilimento si indebolisce e torna fuori l’arcaico. La seconda è che la civiltà, come voleva Freud, è sempre una conquista precaria. Quasi ottant’anni di vita occidentale in tempo di pace ci hanno fatto dimenticare che l’ingentilimento collettivo è una condizione fragile che poggia sul benessere percepito e sull’educazione (cioè sulla repressione), e anche per questo lascia dietro di sé una forma di disagio. Allo stesso modo hanno fatto dimenticare che il popolo non è necessariamente buono, e che la massa come modo dell’essere-con-gli-altri è anche il luogo in cui l’arcaico si manifesta. L’incivilimento novecentesco era il risultato di una dialettica virtuosa tra élites e masse: le prime si erano legittimate al fuoco della lotta antifascista, le seconde si facevano rappresentare, e in qualche modo educare, da una classe dirigente che portava le loro istanze a un grado superiore di elaborazione etica e politica. Alla fine del secolo scorso questo equilibrio ha cominciato a rompersi in Europa, e il primo paese nel quale si è sfasciato è l’Italia. Esattamente trent’anni fa, il 27 marzo del 1994, Silvio Berlusconi vinceva le sue prime elezioni. Di Berlusconi si possono dire molte cose, e se volessimo parlarne davvero dovremmo organizzare un altro incontro. L’aspetto che ci interessa di più in questa sede è che Berlusconi era completamente estraneo all’habitus della vecchia classe dirigente: benché fosse miliardario, sapeva ridurre la distanza che lo separava dai suoi elettori parlando il linguaggio semplificato della comunicazione di massa, come succede oggi con Trump. La sua vittoria era in primo luogo il segno che il rapporto tra masse ed élites si stava trasformando in senso populista.
Negli ultimi decenni le maggioranze hanno smesso di delegare a classi dirigenti troppo diverse da loro; e da quando internet e i social network hanno consentito a tutti di prendere la parola scavalcando i corpi intermedi, il processo si è fatto più veloce e più violento. Il risultato è una sorta di nuova ribellione delle masse che assomiglia a quella degli anni Venti e Trenta del Novecento. Ma le ribellioni delle masse, come diceva Ortega y Gasset, sono anche grandi fenomeni di iperdemocrazia: sono il segno che le distanze decrescono, che il corpo sociale si livella e che i privilegi si redistribuiscono, a cominciare dalla presa di parola. In questo senso i populismi regressivi, come si diceva, sono più democratici delle democrazie illuminate. In generale, l’illuminismo politico si basa su una dialettica fra istanze contraddittorie: non c’è rischiaramento senza élites, e inversamente le élites hanno in sé un elemento paternalistico (o maternalistico) che contrasta con la democrazia. I philosophes illuministi del Settecento volevano il dispotismo illuminato, non la democrazia, come ricordava Bauman; e questo, dopo la Rivoluzione francese, è diventato inaccettabile.

3. Negli ultimi anni le guerre culturali sembrano aver rimesso in discussione l’idea che la Western way of life, contrariamente a quello che pensano i suoi oppositori, sia un’entità unitaria di cui si può parlare al singolare. Come sempre succede in questi casi, il senso di coesione o disunione è legato alla distanza dalla quale si guardano i fenomeni; ma anche se si accetta l’idea che le differenze interne alla forma di vita occidentale siano incomponibili, esiste, tra queste differenze, un elemento comune che le guerre culturali non mettono mai veramente in discussione.
Qualche anno fa, nella biblioteca di Berkeley, c’era un cartello che diceva YOU’RE IN BEAR TERRITORY, il bear, l’orso, essendo la mascotte dell’università. Poi proseguiva così: no discrimination, no fear, no hate, no intolerance; no hate for race, sexual orientation, religious beliefs, disabilities. Una scritta simile rifletteva la critica woke alle discriminazioni, alle gerarchie simboliche e all’idea di normalità che il fondo patriarcale e coloniale della società americana ed europea continua a imporre. Interessante però che mancasse ogni riferimento alla forma di discriminazione su cui il pensiero politico ottocentesco e novecentesco ha insistito di più: la classe. «Siamo tutti borghesi», scriveva Pasolini nel 1968 su «L’Espresso»; «la storia del mondo è diventata storia borghese» diceva a Ferdinando Camon in un’intervista del 1969, perché la classe media scolora su tutto e assorbe la classe operaia, i contadini, i sottoproletari, quello che all’epoca si chiamava il Terzo Mondo: è inevitabile che la modernità (nel lessico di Pasolini “l’industrializzazione”) porti a questo. Profezia discutibile, forse, ma che contiene un elemento di verità; perché tra le tante cose implicite nell’idea che le classi medie abbiano vinto c’è la consapevolezza che non esiste più alcun soggetto politico, proletario o genericamente popolare, capace di lottare per un progetto di società diverso da quello capitalistico, individualistico e, in senso lato, borghese. Certo, le classi medie rimodellate dalla mutazione antropologica sono molto diverse da quelle tradizionali (e il primo ad averlo capito perfettamente è Pasolini): il trionfo dell’individualismo borghese ha distrutto, in mezzo a tante altre cose, l’ethos borghese di una volta. Ma la parte davvero interessante della riflessione di Pasolini è quella che segue. Il trionfo delle classi medie, dice Pasolini, non comporterà la pacificazione della società: «il futuro non sarà un atroce limbo ma una bolgia» piena di guerre che la borghesia combatte con se stessa. E il Sessantotto, nella lettura che ne dà Pasolini, è il primo esempio di un conflitto intraborghese nel quale la nuova classe media trasformata dalla mutazione antropologica combatte senza tregua con la vecchia per imporre nuovi costumi:
Il dilemma che qui si pone è questo: Guerra Civile o Rivoluzione? […] Gli studenti stan facendo oggi la Guerra Civile, non la Rivoluzione: e si tratta semplicemente di una lotta che la borghesia combatte con se stessa.
Le culture wars contemporanee di fatto sono questo: guerre civili interne a un mondo che, per quanto diviso, accetta quasi senza saperlo le ascisse e le ordinate della forma di vita borghese, battaglie tra chi combatte per il compimento pieno, woke, dell’emancipazione individualistica liberale e chi resta attaccato ai residui di un ethos arcaico che faceva parte dei valori della vecchia borghesia e, aggiungo, delle classi popolari di una volta. Da un certo marxismo culturale e dal decostruzionismo, la wokeness ha ereditato il gesto di denaturalizzare e politicizzare tutto, giustamente, mettendo in discussione il senso comune, l’ethos condiviso, il linguaggio, i generi sessuali. L’unica cosa che fatica a denaturalizzare e politicizzare è il capitalismo, sia perché non ha un altro modello sociale plausibile da proporre, sia perché una parte consistente della cultura woke ha smesso di percepire il capitalismo come un sistema che produce e riproduce l’ingiustizia; e anche quando lo fa, non mette mai questo tipo di critica dove dovrebbe stare, cioè al centro del discorso. L’emancipazione che persegue è di tipo individualistico-liberale, la storia di cui vuole il compimento è, di fatto, la storia borghese. Beninteso, un’emancipazione simile è cosa buona e giusta, così come è giusto ridiscutere i privilegi legati al sesso, all’etnia o alla cultura. È ovvio che sia così. Meno ovvio è smettere di vedere quello che una volta gli intellettuali di formazione marxista come Calvino e Pasolini vedevano perfettamente: che la prima forma di ingiustizia nasce dai rapporti di classe.
Non ho la minima idea di come si esca da un’impasse simile né di cosa possa riservare il futuro. Certamente la fase che l’Europa e gli Stati Uniti stanno vivendo in questi decenni è tutto tranne che una belle époque. Si vedono bene le crepe di un modello che non regge più come una volta, ma non circola, nel dibattito pubblico, l’idea che un altro mondo sia possibile. Una frase celebre, attribuita ora a Žižek ora a Jameson e ripresa da Mark Fisher nel suo Realismo capitalista, dice «è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo». Ed è così: per chi ha meno di quarant’anni la mancanza di un modello sociale alternativo non è più neanche un problema, se non qualche volta, e sempre a parole; il nostro immaginario letterario, cinematografico e televisivo è pieno di apocalissi finzionali, ma il nostro immaginario politico non riesce a pensare non dico una rivoluzione, ma nemmeno una socialdemocrazia decente.

Opere citate:
I. Calvino, La «belle époque» inaspettata (1961), ora in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 2007, pp. 90-95.
E. Berlinguer, Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni, “Rinascita”, 28 settembre 1973.
E. Berlinguer, Via democratica e violenza reazionaria, “Rinascita”, 5 ottobre 1973.
E. Berlinguer, Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile, “Rinascita”, 12 ottobre 1973.
P.P. Pasolini, Scritti corsari (1975), ora in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. de Laude, Milano, Mondadori, 1999, pp. 265-535.
F. Bas, La ‘Majorité silencieuse au la bataille de l’opinion en mai-juin 1968, in 68: Une Histoire collective, 1962-1981, sous la direction de Ph. Artières et M. Zancarini-Fournel, Paris, La Découverte, 2008, pp. 359-366.
World Economic Outlook Database, International Monetary Found: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
D. Eribon, Retour à Reims (2009), trad. it. Ritorno a Reims, Milano, Bompiani, 2017.
P.P. Pasolini, Perché siamo tutti borghesi (1968), ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. de Laude, tomo I, Milano, Mondadori, 1999, pp. 1651-58: 1651.
P.P. Pasolini, Intervista rilasciata a Ferdinando Camon (1969) ora in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. de Laude, Milano, Mondadori, 1999, pp. 1626-1646: 1634-1635.
Aa.Vv. Die große Regression. Eine internationale Debatte über die geistige Situation der Zeit (2017); trad. it. Aa. Vv., La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo, a cura di Heinrich Geiselberger, Milano, Feltrinelli, 2017.
J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (1930); trad. it. La ribellione delle masse, Torino, Tea, 1988, p. 40.
Z. Bauman, Legislators and Interpreters. On Modernity, Post-modernity and Intellectuals (1987); trad. it. La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti, Torino, Bollati Boringhieri, 1992.
M. Fisher, Capitalist Realism. Is There No Alternative? (2008); trad. it. Realismo capitalista, Roma, Nero, 2018, pp. 25-42.