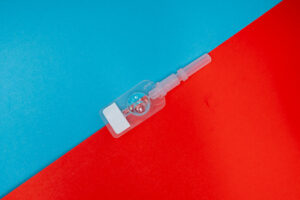«Circa due anni fa sono tornato in Russia. E da circa due anni sono in prigione. Quando scrivi un post del genere, vuoi o non vuoi, finisci per chiederti: quanti di questi post celebrativi bisognerà ancora scrivere?». Con queste parole Aleksej Anatol’evič Naval’nyj – o più probabilmente il suo ufficio stampa – lo scorso 17 gennaio rievocava sul suo canale Telegram il secondo anniversario del proprio ritorno in Russia che, molti ricorderanno, ha coinciso con un arresto scandaloso seguito da imponenti e lunghe proteste in massa nelle maggiori città del paese.
Per l’occasione, ho riguardato il documentario del canadese Daniel Roher Navalny, prodotto da HBO Max e CNN, lo stesso che un paio di settimane fa è stato dichiarato vincitore agli Oscar. Il film riassume la cronistoria dell’indagine condotta da Bellingcat e dallo stesso Naval’nyj durante i mesi della sua riabilitazione in Germania, in seguito all’avvelenamento da lui subito, lo ricorderemo, il 20 agosto 2020 su un volo di ritorno a Mosca dalla città di Tomsk. Oltre a raccontare in modo semplice una storia complessa, Navalny concentra e intreccia elementi rappresentativi multi-genere, dal classico documentario alla spy story, dalla biografia romanzata alla satira politica. Il suo scopo, evidentemente, non è solo quello di ricostruire i momenti cruciali dell’inchiesta sull’avvelenamento, ma anche quello di restituire un ritratto di colui che, forse ancora oggi, sembra essere il più credibile oppositore al governo di Vladimir Putin.
La narrazione di Navalny inizia con gli istanti precedenti l’arrivo in aereo del protagonista da Berlino a Mosca. Intervistato mentre siede nervosamente al suo posto, Naval’nyj definisce quest’ultimo viaggio il “volo della vittoria” (rejs pobedy), quasi a marcare la sua rivincita sull’attentato di alcuni mesi prima.
Dagli ultimi attimi di libertà, la pellicola torna indietro nel tempo, narra il percorso politico di questo “affascinante avvocato”, tenta di riabilitarlo agli occhi di chi, in Occidente, ancora non fosse riuscito a perdonargli le sue controverse passate “frequentazioni” con l’estrema destra nazionalista russa. Roher ripercorre la storia di Naval’nyj, recuperando materiali dal suo canale YouTube e dai media occidentali, e restituisce l’immagine del leader di un’organizzazione composta da gente colta e intelligente che ha a che fare poco o nulla non solo con Putin e la sua corte, ma anche con gli oppositori di generazioni ormai sepolte, poco importa che si tratti di Vladimir Žirinovskij o di Eduard Limonov. Leonid Volkov, Maria Pevčic, Kira Jarmyš e i molti altri rappresentano una generazione cresciuta con internet, l’accesso a fonti d’informazione indipendenti, la possibilità di viaggiare e la concreta aspettativa che dopo i cosiddetti “malvagi anni Novanta” la Russia si sarebbe trasformata in una democrazia.
Il ritratto politico di Naval’nyj si staglia su questo sfondo ed è arricchito dalla descrizione umana del buon manager, del padre di famiglia dedito e affettuoso e dell’uomo adulto che indulge volentieri con videogiochi e clip su TikTok. Durante tutto il film viene da chiedersi se sia effettivamente questo Naval’nyj il “feroce razzista” descritto, pochi giorni dopo il suo arresto, dalla europarlamentare Clare Daly. Accusando il Parlamento europeo di russofobia e doppi standard, Daly aveva, infatti, protestato contro l’incoerenza dei suoi colleghi indignati dall’arresto di Naval’nyj, ma non da quelli di Pablo Hasél e di Julian Assange.

Comunque sia, Navalny resta un film autobiografico, giacché il principale tra gli intervistati da Roher è proprio l’oppositore russo che parla di sé, del suo avvelenamento, dell’indagine condotta brillantemente a riguardo con l’aiuto di Christo Grozev. E non rappresenta un prodotto isolato, nato dal nulla su iniziativa di un regista occidentale. Considerando l’attività investigativa e documentaristica condotta per anni da Naval’nyj stesso e dalla Fondazione anticorruzione, ho avuto l’impressione che Navalny ne internazionalizzi lo stile politico e le strategie comunicative, che porti all’opinione globale ciò che era stato fatto in Russia con altri documentari-inchieste, soprattutto Non chiamatelo Dimon e Il palazzo di Putin. D’altronde, la compartecipazione di Naval’nyj alla produzione del documentario viene messa in chiaro fin dalla scenetta iniziale, in cui è lui a spiegare a Daniel Roher come dovrà essere il film:
«Allora, Aleksej. Vorrei parlare di un argomento che abbiamo toccato in parte stamattina e non ti piacerà, ma vorrei davvero che ci pensassi su. Se venissi ucciso, quale messaggio vorresti lasciare al popolo russo?».
«Ma dai, Daniel. No, non esiste. È come se stessi girando un film che uscirà quando sarò morto. Sono pronto a rispondere alle tue domande, ma facciamo che sia un altro film. Proviamo a rendere questo film un thriller e, in caso venissi ucciso, lo trasformerai in un noioso film in memoria».
Per tutta la durata del film, ho pensato molto a questo incipit, all’ironia con cui si pone rispetto agli esiti del ritorno in patria del suo protagonista. Che non è (ancora) stato ucciso. Col senno di poi, si sa, è facile parlare, ma è ormai piuttosto evidente che il giorno del suo ritorno e arresto ha simbolicamente segnato in Russia l’inizio della fine dello stato di diritto. Di conseguenza, mi sono chiesta cosa sarebbe successo se avesse deciso di non tornare. Risposta scontata: in esilio avrebbe potuto continuare a portare avanti la sua attività politica. Sì, ma per chi, per gli occidentali? Non necessariamente. Non siamo più nell’Ottocento o ai tempi dell’Unione Sovietica, quando gli émigrées perdevano completamente, o quasi, ogni comunicazione con chi restava in Russia.
E così, mi è venuta voglia di rileggere Dall’altra sponda di Aleksandr Herzen (1850), l’atto definitivo della disillusione di un emigrato russo in Europa, socialista inorridito dalla Rivoluzione di Parigi del 1848. In una lettera, posta all’inizio degli scritti che compongono l’opera, Herzen si rivolge ai suoi amici e compagni di idee rimasti a Mosca, spiegando le sue ragioni per non tornare in patria: «L’autocrazia, incattivita e impaurita da tutto quanto avviene in Europa, soffoca con raddoppiato accanimento qualsivoglia moto dello spirito e isola brutalmente sessanta milioni di uomini dal resto dell’umanità, in procinto di emanciparsi» (Dall’altra sponda. Adelphi, 1993, p. 42).
La percezione che a distanza di due secoli Herzen e Naval’nyj hanno della Russia è simile: un regime autocratico, separato dal resto del mondo ma soprattutto dall’Occidente, per riprendere il post di Naval’nyj, un paese «trasformato in una prigione comandata dai mascalzoni più bugiardi e senza coscienza», ma che, ciononostante, «sarà felice». Anche gli scopi di entrambi vanno nella stessa direzione: aspettare o, se possibile, fare in modo che la violenza dello Stato sui cittadini finisca. Ciò che li distingue è probabilmente una diversa percezione del proprio destino, che per Naval’nyj è ancora in parte da scrivere. Tornando in Russia per farsi arrestare ha fatto proprio ciò che Herzen stigmatizza nella sua lettera agli amici, ossia immolarsi per un ideale civico, anziché continuare a lottare in Europa, al sicuro davanti a un’opinione pubblica e dei cittadini non completamente annichiliti dalla propaganda e dalle repressioni.
Se il 17 gennaio 2021 Naval’nyj non avesse preso quell’aereo, oggi sarebbe ancora libero. Ma da questa sponda, che suono avrebbe la sua promessa che la Russia «sarà felice»?