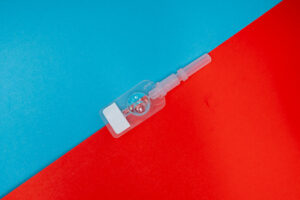«Sei bravo» è il pretesto per non seguirti.
«Sei giovane» quello per non pagarti.
A ventott’anni suonati hai deciso di suicidarti col paracadute e così ti sei iscritto al concorso per il Dottorato di Ricerca (disciplina umanistica). Sei giovane, scoppi di salute, le tue forze intellettuali non aspettano altro che essere affogate in qualche cubicolo universitario. Non hai sponsor, protettori, segnalazioni. E infatti vinci «senza borsa», dopo uno scritto dal sapore paraculo (al sorteggio è uscito Le forme della poesia in un periodo storico a vostra scelta, chissà gli altri due) e un orale da guerra balcanica, coi cecchini che alla prova di lingua straniera ti hanno messo sotto gli occhi un ritaglio di fotocopia in quel middle-english del cazzo.
Dodici anni dopo sei ancora lì, geostazionario intorno alla Cattedra-di, col beneplacito (leggi: la tolleranza) del settore L-FIL-LET/10 e un Preside pronto a sacrificarti alla prima Abilitazione Nazionale. Continuano a dirti che sei bravo e sei giovane.

Nella percezione accademica del Creato la differenza che corre tra un Professore Ordinario e uno come te – aggrappato come un naufrago alla definizione di «cultore della materia» – potresti agevolmente misurarla, affidandoti a quell’infallibile mappa che è il disegno leonardesco dell’Uomo Vitruviano, lungo la bisettrice che corre perentoria dal centro della fronte all’interstizio rettale.
“Cazzo! A quarant’anni finalmente ce l’ha fatta: è diventato ricercatore!”
Il Miraggio viene a te sotto le spoglie del Posto-di-Ricercatore. Per entrare all’università si deve passare da questa porticina angusta. Ed è come precipitare dentro un wormhole, nell’abisso psichedelico dell’inversione. Chi sta al di qua del Ricercatore esclama: «Cazzo! A quarant’anni finalmente ce l’ha fatta: è diventato ricercatore!», chi sta al di là del Ricercatore bofonchia: «Chi? Ah, quel poveraccio di un quarantenne che è ancora ricercatore». Vizzi studenti del Dottorato di Ricerca guardano al de cuius, per la sua fresca nomina, come a un uomo di successo, un drago, un modello di virtù tecnopolitica. Ordinari sul mezzo secolo – compresi quelli che hanno brigato parecchio per garantire la sua ascesa al sospirato ruolo – lo osservano con sospetto: «Ecco un altro che adesso comincerà a rompere il cazzo per diventare Associato».
Gli studenti ti vedono sorseggiare un caffè davanti allo studio di Antichità Puniche e ti scambiano per l’antichità punica. Se sollevi un braccio per salutare il Direttore del Dipartimento che sta entrando in sala riunioni, quello prende e ci poggia l’impermeabile. Dottorandi novelli fomentati dal Potente Ordinario di turno prendono possesso della tua scrivania e ci installano sopra un megacomputer protetto da password e striscioline di carta che un gran pennarello rosso ha intriso a sangue con un elegantissimo NON TOCCARE, come se ungere di fluidi digitali la roba degli altri fosse la tua più conosciuta proterva abitudine.
Qualcuno continuava a ripeterti “Aspetta, verrà il tuo turno”, poi non si sa come sei finito nell’angolo
Sei vecchio, hai passato i quaranta, ne hai sopportate tante che ormai ci hai fatto il callo, ti sembra ieri che sfrecciavi per le sale di lettura di mezzo mondo come un falco pellegrino e dominavi in scioltezza il complesso panorama dei repertori bibliografici. Eri un infaticabile lettore, pieno d’intuito e avido d’interpretazione, avevi l’occhio clinico per i fenomeni di stile, un talento innato per la metrica e le tasche gonfie di sogni riformatori. Eri la promessa in attesa di realizzazione, finché qualcosa non ti ha spento. Qualcuno continuava a ripeterti: «Aspetta, verrà il tuo turno», poi non si sa come sei finito nell’angolo, nello studiolo infestato da usurpatori di cancelleria. Vieni mobbato perfino dalle signore delle pulizie, che ogni tanto sorprendi in atroci sghignazzi, perché qualcuno – non saprai mai chi – si è premurato d’informarle che tu sei la Nullità, l’Archetipo del Fallimento: quello che ancora-ci-prova.
Nel frattempo ti sei fatto amici particolari, filologi che costipati da arcane speranze svolgono konvolut di papiri destinati a rivoluzionare l’interpretazione di oscuri epigrammisti da Antologia Palatina: gente come Nosside di Locri (lesbica e poetessa), Anite di Tegea (animalista e poetessa), Edilo di Samo (gozzovigliatore e poeta). Nomi di un Regesto dell’Oblio per scrittori di cui non frega una cippa a nessuno, salvo un irriducibile manipolo di studiosi sparsi qua e là per l’attempata Europa. Melma ellenistica, ciarpame alessandrino, ma puoi scommetterci le palle che in qualche insalubre sotterraneo tra Oxford e Friburgo troverai sempre il disadattato che ha stabilito di dedicargli una vita di fervore. La preziosa luce della scoperta, tra biblioteche fetenti di polvere e luteranesimo.
Il Dottorato funziona come il poker, il gioco, a ogni mano, è mandare via più gente possibile
La verità è che hai resistito dodici anni perché sei ricco di famiglia, reggere era diventato una specie di duello di nervi coi tuoi superiori. «Sono ancora qua, non me ne vado». Perché il Dottorato funziona come il poker, il gioco, a ogni mano, è mandare via più gente possibile. Come tutti gli altri, anche quelli con borsa ma senza patrimonio, già dopo la discussione della tesi avevi capito che era finita. Quei tre anni servono più che altro a farti perdere qualsiasi capacità lavorativa, a toglierti da colloqui e occasioni, mentre assapori la gloria di un’élite immaginaria. Perché, già, in quegli anni eri comunque il satellite della Cattedra-di, l’inviato della Cattedra-di, la staffetta della Cattedra-di.

Fluttuavi leggiadro tra un vernissage e un simposio, abbottonandoti nel conforto della tua giacca di velluto e ovunque impugnando lo stesso bicchiere con dentro la stessa oliva trafitta dallo stesso stuzzicadenti che galleggiava nello stesso Martini, trovando il modo di intrecciare la tua vicenda di Misterioso Emissario della Cattedra-di con quella di un numero sconcertante di scrittrici di poemetti vedici, intarsiatori di haiku, vecchie glorie impoltronite delle Patrie Lettere, editori senza scrupoli, politici collezionatori di prime edizioni del Novecento, vedove di luminari, vedove di Premi, vedove tipografiche.
Sarebbe bello dire che a un certo punto hai volontariamente smesso. Ma no. Ma proprio no, perché sei tignoso. E anche stronzo.
Ti scassa il cazzo tutti i giorni con riunioni interminabili in cui si parla – cioè: lui parla – dell’autore che riscuote il suo febbrile, ancorché transitorio interesse
Sei nell’ufficio di un Professore Ordinario di Letteratura Italiana con delega alla direzione di un Dipartimento, e che incidentalmente è il tuo capo. Il capo, forse per «conforto e vendetta» su lunghi quanto irrilevanti studi ariosteschi, è soggetto a frequenti innamoramenti per autori stranieri. Fiammate che durano un paio di mesi, poi gli passa. Ma in quei due mesi ti scassa il cazzo tutti i giorni con riunioni interminabili in cui si parla – cioè: lui parla – dell’autore che riscuote il suo febbrile, ancorché transitorio interesse.
È il bimestre di Mordecai Richler. E meno male, se non altro ha tirato fuori uno scrittore degno di questo nome.
Nello studio siete una mezza dozzina: dottori di ricerca, dottorandi, praticamente la redazione della rivista di cui lui è al comando. Rivista realizzata in combutta con un famigerato editore-sparviero del sottobosco capitolino. Il capo ci pubblica i suoi saggi in apertura: una volta ha scritto venti pagine su un endecasillabo ipermetro in Montale (quattordici sillabe, perbacco!) senza rendersi conto che era un alessandrino (e senza che uno dei dottorandi adibiti alle bozze se ne accorgesse). Ciononostante, circondate il capo, su sedie, sgabelli, strapuntini: lo surroundate. Di fatto, siete la sua cerchia.

Lui si accende un toscano:
«Ragazzi, non è meraviglioso Mordecai Richler? Con quella lingua fintissima, ma così vera».
L’ossimoro è la figura retorica prediletta dagli imbecilli. E – pura statistica – dai «creativi». Nel senso che gli uni e gli altri non si risparmiano con l’ossimoro, appena te ne possono infiocchettare uno, ecco là.
«Che poi questo Barney l’ho trovato sontuoso. Voglio dire, ti innamori di lui. E ti stai innamorando di un assassino».
«Come, scusa?».
«Ti innamori di un assassino».
Lo ha ripetuto adagio, solo per te, per lasciarti accarezzare la perfetta economia, anche nuda, brillante, della sua sensibilità.
«No, guarda che Barney non ha ammazzato Boogie. Nell’ultima pagina Michael si rende conto che Boogie è stato preso dal canadair mentre faceva il bagno nel lago. Poi il canadair l’ha rovesciato insieme all’acqua sulle montagne».
«E come l’hai capito?».
«C’è scritto».
Boccata di toscano. Sguardo truce, di quelli che soltanto una massiccia carica di vuoto interiore sa partorire. Fine della tua carriera universitaria.