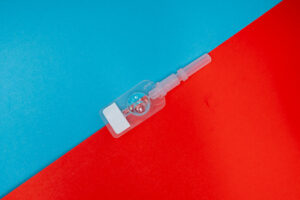La notte prima della trasferta a Birkenau l’ho passata in compagnia di un professore tedesco del Convitto Nazionale che per un paio d’ore ha provato innocentemente – ma con ogni mezzo possibile, pianto incluso – a rovesciarmi addosso il senso di colpa di un’intera nazione.
Dato che dopo cena si era aperto il dibattito coi testimoni, finì che ci ritirammo verso le due di notte. Alle quattro il mio compagno di stanza era sconfitto dalla sua inconsolabile logorrea: spense l’abat-jour e sprofondò la testa nel cuscino. La notte polacca, in quel novembre del 2008, non saprei descriverla, perché il medio comfort della nostra doppia standard azzerava qualsiasi cognizione spaziale. In borsa, insieme a un classico di Hannah Arendt e a due macchine fotografiche, avevo messo il dvd di Jurassic Park. La sveglia era prevista per le sei del mattino. Calcolando che mi ero addormentato più o meno quando Dennis Nedry viene sbranato dal dilofosauro, avrò dormito sì e no tre quarti d’ora.
Queste trasferte “della memoria” iniziano dal piazzale di un albergo dalle parti di Cracovia e finiscono dritte sulla Judenrampe. Sotto il titolo di “referente” per i Viaggi della Memoria del Comune di Roma ero lì come accompagnatore di studenti selezionati tra diverse scuole della Capitale. L’organizzazione è feroce: si arriva nel gelo del mattino, lontano dai cancelli, la notte ti hanno fiaccato col dibattito e mandato a letto tardissimo, sei a pezzi e devi farti tutta la camminata fino all’ingresso di Birkenau, una marcia spossante, provano a darti un assaggio di cos’era scendere lì da un treno e sentire liquefarsi i muscoli delle gambe mentre non riesci quasi a respirare dal freddo. Sadismo come obbligo documentario, niente da eccepire.
Io ero responsabile di quattro studentesse all’ultimo anno del cosiddetto Socio Psico Pedagogico, in un istituto cattolico di suore missionarie
Nel piazzale i pullman tremolavano coi motori accesi, il fumo saliva in un’aria di crisalide – panorama piatto, si pensa subito che la Polonia è un posto triste, un posto davvero triste, dilatazione in povero della Bassa, senza profumi né buona cucina, una magra aggettivazione di alberetti che salgono dalla terra raggrinzita, uno schifo. Prendemmo posto sui convogli. Io ero responsabile di quattro studentesse all’ultimo anno del cosiddetto Socio Psico Pedagogico, in un istituto cattolico di suore missionarie, di quelle che non si fanno chiamare sorelle ma madri. Alla compilazione delle liberatorie per il viaggio la preside, una «madre» che insegnava filosofia e venerava Kant, mi aveva chiesto cosa volesse dire quel termine spuntabile – kosher – sui moduli per i pasti. Alla prima spiegazione aveva dato segni infastiditi di perplessità. A me pareva che si rifiutasse di capire, tanto per far capire a sua volta quanto considerava astruse le regole della Casherut, se confrontate all’onnivora superiorità del cristianesimo. Potrei dire che faceva la stronza. E siccome sono geneticamente portato per le gare a chi è più stronzo, ero andato a pescare un esempio in Mordecai Richler, lo scrittore più stronzo che conosco. «Immagini, madre, un aereo che precipita fra i ghiacci. A bordo ci sono un ebreo, suo padre e il pilota di colore. Il padre e il pilota muoiono nello schianto, e l’ebreo è costretto al cannibalismo per sopravvivere. Chi mangerà? Suo padre o il pilota nero?». «Il pilota!». «E lo vede che non ha capito niente? Mangerà il padre, perché almeno sarà un pasto kosher».
Questo contenuto è visibile ai soli iscritti
Snaporaz è una rivista indipendente che retribuisce i suoi collaboratori. Per esistere ha bisogno del tuo contributo. Accedi per visualizzare l'articolo o sottoscrivi un piano Snaporaz.